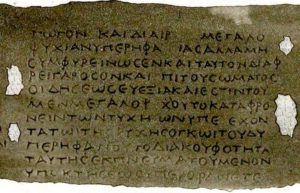Ho fra le mani due lettere. Di due madri che combattono al fianco dei loro figli con malattie, disabilità così gravi che tutta la loro vita hanno assorbito… e potete immaginare i decenni di fatica, difficoltà, dolore… Cui si aggiungono ostacoli che diventano muri, che meccanismi della nostra società spesso oppongono loro, respingendo, oltraggiando anche… Leggo dell’una e leggo dell’altra, storie diverse, e così eguali se entrambe sentono il bisogno di rendere pubblico il dolore di questo momento più difficile di tanti altri pur attraversati.
Pensavo di estrarne stralci, da commentare, magari. Ma difficile trovare parole più chiare e forti delle loro. Quindi ve le sottopongo nella loro interezza.
Solo qualche cenno.
La prima è di Gabriella La Rovere, che è medico e scrittrice, e da sempre si batte per dare voce, attraverso la sua esperienza, alle condizioni di chi vive situazioni cliniche e familiari difficili, per provare a scuotere coscienze. Denuncia un sistema che nega il ricovero nella struttura sanitaria di cui sua figlia ora ha bisogno.
La seconda è di Elena Improta, fra l’altro impegnata da sempre nelle politiche sociali, presidente della Onlus “Oltre lo sguardo”. E’ una richiesta di aiuto per giovane uomo gravemente disabile in causa da 26 anni per risarcimento danni da parto, e che ora si sente comprensibilmente “oltraggiata” da una sentenza che respinge il risarcimento e condanna lei e il figlio “al pagamento delle spese per un importo talmente spropositato da apparire punitivo e dissuasivo…”
Leggete…
Avere una figlia con una malattia rara significa convivere con un dolore sordo, costante, ed esserne anche il medico carica tutto di lacerante consapevolezza, di pesanti responsabilità.
La sclerosi tuberosa è una malattia bastarda nella quale le formazioni tumorali (di solito benigne, ma non è detto!) interessano tanti organi danneggiandone la funzione. Ed ecco perciò l’epilessia non controllata dai farmaci, il ritardo mentale, l’autismo, la lenta evoluzione verso l’insufficienza renale, il possibile interessamento polmonare, cardiaco, e così via.
Mia figlia ha anche un aneurisma del sifone carotideo sinistro, una complicanza ancora più rara all’interno della sua straziante rarità, che le conferisce l’onore (!) di essere il 19esimo caso al mondo. La scelta di cosa fare è spettata a me, e mentre la parte materna urlava il suo dolore contro il Cielo, quella professionale valutava i pro e i contro di un intervento chirurgico rischioso che poteva portare a conseguenze ancora più gravi, considerava la paziente nella sua particolare unicità e optava verso una vita piena, degna di essere vissuta per tutto il tempo che le sarebbe stato concesso.
Pensavo che tutto questo fosse più che sufficiente, invece la vita mi ha posto davanti un altro mostro contro il quale è difficile, quasi impossibile combattere: la schizofrenia e l’evoluzione psicotica grave che trasforma mia figlia in un essere rabbioso, con occhi e voce diversi, e che nel novembre 2019 ha tentato più volte di aggredirmi, fino a riuscirci. La nostra vita è cambiata, i momenti di serenità sono pochissimi perché vivo nella paura della sua perdita di controllo ad ogni minimo imprevisto. L’interessamento ingravescente cerebrale l’ha resa molto incerta nel camminare e a tutt’oggi non sono sicura che non possa perdere la coordinazione motoria portandola all’uso della sedia a rotelle.
È indubbio che le nostre esistenze debbano dividersi ed è qui che inizia un’altra brutta storia, fatta di omissioni e “leggerezze”. Attualmente, quando una persona autistica diventa maggiorenne, passa in carico al Centro di Salute Mentale (CSM) del proprio territorio che, il più delle volte, non ha la giusta competenza per affrontarne il complesso mondo, riducendo il tutto a carichi di farmaci, spesso in grado di innescare effetti paradossi.
Nonostante ripetute segnalazioni – le mie e quelle di due operatrici di una cooperativa che collabora con il distretto sanitario, una delle quali aggredita fisicamente – da più di un anno il CSM è inadempiente nell’autorizzare l’inserimento di mia figlia in una residenza sanitaria. In Umbria, dove viviamo, c’è l’Istituto Serafico di Assisi, struttura molto qualificata sia dal punto di vista pedagogico-abilitativo che medico. L’inserimento sarebbe possibile perché c’è posto e mia figlia vi ha già trascorso 30 giorni, in seguito al nullaosta del Giudice Tutelare del Tribunale di Spoleto al quale avevo sottoposto il caso e che aveva convenuto l’esattezza della mia richiesta.
Sorvolo, ma non dimentico, la gogna alla quale sono stata sottoposta con insinuazioni becere di voler “rinchiudere” mia figlia, di essere una donna “psichicamente provata”. Sono sopravvissuta a Bettelheim e, per fortuna, la medicina è una scienza, non mero empirismo
In tutto questo tempo (perso) il CSM e il Distretto Sanitario hanno affermato a voce che non ci sono i soldi e, su suggerimento delle assistenti sociali, continuano a proporre una residenza socio-assistenziale perché più economica, a dispetto del quadro clinico, indiscutibilmente grave. A questo punto non posso che prendere atto che una sanità che, in condizioni di innegabile gravità clinica, opta per il risparmio deve prendersi tutte le responsabilità morali, sociali e penali del caso.
Dott.ssa Gabriella La Rovere
Sono Elena mamma di un giovane uomo di 32 anni affetto da una gravissima disabilità, oltraggiato dall’esito ad oggi di una causa civile di risarcimento per i danni subiti al parto, iniziata nell’aprile 1996 presso il Tribunale di Roma ….Il diritto di Mario ad un giusto processo è stato innanzitutto violato e calpestato da 26 anni di causa , devastanti da un punto di vista emotivo, psicologico ed economico, durante i quali ho sempre mantenuto fiducia nella Giustizia e nell’Ordinamento Giudiziario.
Oggi, per la prima volta in questi 26 anni di silenziosa e fiduciosa sofferenza, alla vigilia del mio 59mo compleanno, sono costretta a dare voce al mio sgomento ed incredulità davanti all’esito incomprensibile della causa in sede di rinvio…
La Corte di Cassazione nel 2017 riconosceva che doveva ritenersi provata l’esistenza di nesso causale tra la condotta omissiva dei medici e la patologia subita dal paziente
Oggi dopo 5 anni dopo un iter quanto meno tortuoso ed incoerente la Corte di Appello ribalta le conclusioni della Corte di Cassazione , respinge il risarcimento e condanna me e Mario al pagamento delle spese per un importo talmente spropositato da apparire punitivo e dissuasivo…. Quasi 300mila euro …
Non posso credere che questa sia Giustizia !!!
Mi appello a voi Presidente Mattarella
Presidente Draghi , Ministro Cartabia “
Ho speso la mia esistenza a tutelare i diritti di Mario e non solo !
Ora sono molto provata e stanca sono traumatizzata da questo evento che mi toglie energia per poter prendermi ancora cura di Mario sono spaventata e morta dentro.
Procederò facendo nuovamente ricorso in Cassazione sperando di averne la forza fisica e mentale continuerò a fare sacrifici e privazioni Ma resta l’umiliazione di una madre e di un figlio , restano pochi anni davanti a noi e spenderli con questa prospettiva mi annienta
La magistratura non può permettere tutto questo dopo 26 anni! Come ridurre i tempi della giustizia civile? Come velocizzare questi procedimenti?
I medici in sala parto hanno tolto a Mario l’opportunità di essere una persona neurotipica, i Giudici gli stanno togliendo l’opportunità di vivere dignitosamente da persona con disabilità, peraltro da sempre generosa e pronta ad aiutare altre persone con disabilità… lo abbiamo ampiamente dimostrato negli ultimi 16 anni.
Io e Mario due volte oltraggiati, abbiate compassione per questa nostra lettera
Elena Improta
Difficile aggiungere parole. Solo una breve osservazione, per ricordare che il dolore che ci viene raccontato è il dolore di tante altre persone, di tante altre famiglie, di tante altre donne, soprattutto, perché sono in stragrande maggioranza le donne a farsi carico dell’assistenza di familiari malati. E sono soprattutto figli.
Il rifiuto, che arrivi dal sistema sanitario come per Gabriella o dal sistema giudiziario come per Elena, è l’espressione di un sistema che dimentica cosa sia il diritto alla cura, come pure pensato e sancito dalla legge di riforma sanitaria del ’78, e dove il confronto fra diritti e interessi di soggetti diversi, pubblici e privati, diventa scontro, e non mediazione, nell’abbraccio del cittadino, come dovrebbe infine essere…
scritto per Ultimavoce.it