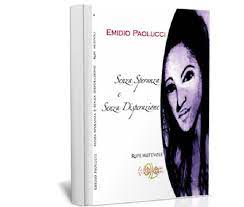Un pensiero forse non troppo politicamente corretto. Forse può far scandalizzare. Eppure lo pronunciamo, questo pensiero “scorretto”: forse non è proprio così male che si trovasse in un corridoio.
Parliamo di Wissem Ben Abdel Latif, tunisino, 26 anni appena, morto nel novembre scorso dopo essere stato legato a un letto per cinque giorni in due diversi ospedali romani (il Grassi di Ostia, dove era stato trasferito dal CPR di Ponte Galeria, poi nell’ospedale San Camillo di Roma).
Sono passati più di quattro mesi dalla sua morte, e sulla tremenda vicenda, sulla sua morte ingiusta, ancora molto è da chiarire, a cominciare dal perché sia stato legato a un letto un giovane che (rileggendo, di flash in flash, brevi cronache) aveva denunciato le condizioni del CPR dove era finito e nei giorni successivi secondo alcuni testimoni sarebbe stato malmenato da uno o più agenti, e dopo non so quali altri “passaggi” si ritrova legato a un letto con diagnosi di “disagio schizo-affettivo”. Muore per arresto cardiocircolatorio. Ora si scopre che “le carte dicono che in quei cinque giorni sia stato alimentato un’unica volta”. L’indagine della procura chiarirà…
Ma intanto, come non fare alcune riflessioni, leggendo del Garante intervenuto con un sopralluogo dopo la denuncia della morte del giovane tunisino e della risposta, alle raccomandazioni ricevute, della Direzione generale dell’ospedale dove Wissem è morto. Se le cose sono anche nelle parole con le quali le pronunciamo…
Ha scandalizzato il fatto che nell’ultima tappa della sua via crucis italiana il giovane tunisino sia stato lasciato, legato al letto, in un corridoio. Senza un minimo di riservatezza. La riservatezza che, certo, avrebbe evitato turbamenti a chi per un motivo o l’altro si trovasse in quel corridoio. La riservatezza che forse avrebbe restituito un minimo di dignità alla sua persona, nascondendo agli occhi di altri il suo stato.
Eppure, eppure… Meglio invisibile? In coerenza con quell’ “invisibilità dei nostri pazienti” che ha accoratamente denunciato in un incontro su questo Forum Carla Ferrari Aggradi, in questa società che rifugge dal dolore…
E non posso che rigirare la domanda a Peppe Dell’Acqua, al quale ormai da anni chiedo conforto, quando parole e dubbi, su certe storie, mi lacerano la mente.
Meglio invisibile, Peppe?
“Penso ai direttori dei manicomi di un tempo che impedivano ai fotografi di entrare nei manicomi per ‘rispetto della dignità degli internati’. Che dire… La questione è altra. Benché da più di qualche anno stiamo immaginando una campagna per abolire la contenzione, questo esercizio di “riduzione” dell’altro continua. Anzi sembra, si sa e non si dice, che sia dominante, e si dice solo quando accadono tragedie come questa, per cui c’è chi se ne occupa.
Ma penso anche che sempre l’attenzione di chi poi interviene, giudice o garante che sia, si limiti a controllare il rispetto di regole, di protocolli che, diciamo la verità, sono stati fatti proprio per permettere che si ricorra a questo brutale esercizio terapeutico. E quali parole critiche per questo “trattamento” in sé? Non ne trovo. Penso alla vicenda della ragazza morta nell’incendio del reparto di Psichiatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre era in un letto di contenzione, dove la procura ha concluso le indagini con la richiesta del rinvio a giudizio di due operai del Pronto intervento anti-incendio! Come se non esistesse un primario, una regione Lombardia che favorito e regolamentato la contenzione. E poi… Negli ultimi decenni sembra non accada niente di cui parlare se non quando muore qualcuno per contenzione o violenza delle cure psichiatriche. Mentre tanto ci sarebbe da dire.
Si sa che abolire contenzioni, porte chiuse dei Diagnosi e Cura, abolire le strutture residenziali… significa cominciare a parlare di cosa debba essere un’organizzazione articolata di servizi di salute mentale, una presa in carico possibile, capace di affrontare questa come altre situazioni”.
E allora, forse non è proprio così male che Wissem fosse stato lasciato in corridoio (insieme ad altri per cui non s’è trovato di meglio), ché magari qualcuno è rimasto turbato, da quel corpo che urlava nel silenzio il suo dolore. E magari qualcuno avrà pure pensato che quello che fa scandalo è piuttosto che quel giovane uomo fosse legato a un letto…
“L’immagine che mi è venuta, pensandoci, è quella di una persona che muore di fame sotto un tavolo di bendidìo… Possibile che nessuno pensi mai che una persona invece che essere contenuta possa essere accudita, accompagnata, circondata da parole e abbracci. E questo è pure possibile, grazie alle associazioni di volontariato, ai tanti giovani che sono presenti quando ci sono buoni servizi, nei Servizi di salute mentale come nei Diagnosi e Cura. Lì dove non si contiene (e sono purtroppo pochi i luoghi dove non si contiene, non più di due ogni dieci servizi di Diagnosi e cura) si ricorre sempre a persone (operatori, cooperative, associazioni) che possono, e sanno farlo, trascorrere anche due tre giorni accanto alla persona che sta male. Mentre per lo più non si fa altro che mettere grate, impedire sguardi altri, impedire spesso persino gli ingressi”.
Scorrendo la risposta data dall’amministrazione dell’ospedale ai rilievi del Garante fa certo piacere leggere della rassicurazione che “siano state attivate azioni di miglioramento organizzativo e strutturale a tutela dei diritti dei Pazienti ricoverati”. Pazienti con la P maiuscola, come se quella maiuscola già da sola fosse un anticipo di restituzione di dignità. Miracoli del burocratese, che a tratti potrebbe anche far sorridere se a tratti qua e là non raggelasse. E un po’ inquieta la considerazione finale del documento che… “gli eventi critici debbano essere occasione di azioni di miglioramento e di trasformazione organizzativa” …
“La lettura dei documenti raggela. Sembra un esercizio di distanziamento dalla realtà di quel Diagnosi e Cura (che è quella della maggior parte dei centri) o comunque di tutti i luoghi di restrizione della libertà. Un distanziamento che cerca di mettere dentro parole che appaiono pulite, tecniche, se non addirittura ‘terapeutiche’, per comportamenti che non sono altro che riduzione, distanziamento, violenza, che vengono esercitate sul corpo delle persone. I rapporti di chi interviene forse dovrebbero riportare sempre che il ricorrere alla contenzione, esercitarla da parte degli operatori, significa radicare, far crescere culture assolutamente distanti da qualsiasi immagine terapeutica; significa raggelare la tensione umana di vicinanza che dovrebbe avere l’operatore, e sono ferite che anche l’operatore poi si porta dietro. Ma bisognerebbe anche ricordare che il problema non è solo quello della morte fisica (accidenti ne accadono sempre). Ci sono le ferite che le persone subiscono, ferite morali, psicologiche. Essere legati, impediti a muoversi ed esercitare quel minimo di presenza che significa stare con gli altri, provoca ferite indelebili che contorcono lo spirito, l’immagine di sé. Esattamente come è accaduto ai sopravvissuti ai campi di concentramento, che hanno dovuto far passare decenni prima di cominciare a parlare. Si è impediti dalla vergogna. Come si fa a dire ‘io sono stato legato per una settimana’?! I giudici dovrebbero interrogare, chiedere di questo a chi subisce la violenza della contenzione. Sì, la lettura dei documenti, il linguaggio burocratese raggela. Questa storia… ma chi era Wissem, da dove è venuto? E perché quando è stato portato nel Diagnosi e Cura, per un ricovero sembra non formalizzato in TSO, dove dobbiamo pensare che protestasse, sia stato poi legato, legato e trasferito… operazioni di un’insensatezza totale. La psichiatria, d’altra parte, per farsi non può che oggettivare l’altro. L’altro, ora oggetto senza più nome e senza più diritto diventa povero corpo, scompare allo sguardo. Le sue parole non possono più essere ascoltate..”
E chissà che ne pensa Wissem, di tutto il bene che discenderà dal suo essere stato “evento critico”…
“Credo che resterà molto deluso. Questi ‘eventi critici’ non fanno altro che incentivare le forme di controllo meccanico, l’addestramento del personale alla lotta non alla holding. Eppure, bastava che ci fosse qualcuno che avendo uno sguardo libero dalle psichiatrie, capace di mettere tra parentesi la diagnosi e valorizzare la sua protesta, e forse tutta la storia sarebbe stata un’altra cosa”.
Già. L’ “evento critico” per molti motivi fra l’altro forse evitabile, perché nello Spdc, Wissem non sarebbe mai dovuto finire. Perché, va ricordato, poco dopo la sua morte l’avvocato della sua famiglia, Francesco Romeo, ha spiegato che: “ il 24 novembre, mentre il giovane Wissem era ricoverato e legato in stato di contenzione presso l’Ospedale Grassi di Ostia, il Giudice di Pace di Siracusa sospendeva l’esecutività del decreto di respingimento e del provvedimento di trattenimento presso il CPR di Ponte Galeria (…). Wissem non ne ha avuto notizia, è rimasto ricoverato in stato di contenzione prima al Grassi di Ostia e dopo al San Camillo, ma alla data del 24 novembre scorso avrebbe dovuto essere rimesso in libertà”.
A margine, ma neanche poi troppo. Si rileva, nel rapporto del Garante, l’inadeguatezza alle esigenze dei pazienti dei locali del Spdc dell’ospedale. Con un dehors “spazio di cemento, privo di copertura dagli agenti atmosferici, trovato sporco nel giorno della visita, con arredi {qualche sedia) visibilmente rimediati e non pensati per i pazienti. (…) II muro che lo delimita è oltretutto facilmente scavalcabile”.
“Osservare la miseria dei luoghi, tutti i luoghi della psichiatria, i diagnosi e cura, ma anche gli ambulatori, le strutture residenziali… sono luoghi dove a parte la mancanza totale di etica c’è una questione di estetica… come se il bello, la confortevolezza, la comodità, la bellezza di un arredo non avessero nessun senso per questi luoghi dove le persone, i ricoverati, sono costrette a passare l’intera giornata. Leggo di mobili di questo soggiorno azzurri, come per una scuola per l’infanzia, ed è doloroso vedere i televisori piantati in alto sui muri… E poi le stanze oscurate e sempre con le luci accese, le persiane rotte e sempre abbassate…
E poi si sottolinea che non c’è la sociologa, l’animatore, una terapia riabilitativa, e dalla direzione dell’ospedale si risponde con puntualizzazione di numeri e funzioni… Ma si dimentica che un Spdc è un servizio per l’emergenza, che dovrebbe durare il tempo di un attimo, che la terapia riabilitativa non avrebbe nessun senso se non per essere vicino alle persone e accompagnarle nel corso della giornata. Il TSO non impedisce che una persona possa andare in un giardino, semmai se serve accompagnata. La terapia riabilitativa interna in un Diagnosi e Cura non ha senso”.
E si parla di ora d’aria, come nelle carceri.
“Li ho visti ovunque questi luoghi che vogliono garantire un’ora d’aria. Ai pazienti? Ai detenuti? Ma neanche il TSO comporta un sequestro della persona, ma una negoziazione costante. Qualcuno ha negoziato qualcosa con Wissen?”
Eppure, è ormai accettato che la contenzione non è mai atto terapeutico, basta leggere la sentenza Mastrogiovanni (il maestro morto il 4 agosto 2009 all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dopo essere rimasto legato 83 ore. Medici e infermieri sono stati condannati per sequestro di persona) che lo afferma in maniera inconfutabile.
Tornando all’immagine di quel muretto che mi è rimasto in mente come respiro di punto di fuga… Nella risposta dell’Ospedale ai rilievi del Garante non leggiamo che si pensa di alzare un po’ quel muretto così facilmente scavalcabile (o per lo meno non è specificato). E qui non mi riesce di contenere un pensiero un po’ “anarchico”: speriamo se lo siano dimenticato!
Pensando a Wissem. Non sappiamo se almeno la sua anima sia riuscita a scavalcarlo, quel muretto, appesantita dal macigno di tanto incomprensibile dolore, ma gli auguriamo di avercela fatta. E speriamo che rimanga così com’è quel quasi possibile varco, a suggerire che non la contenzione ma la libertà è terapeutica. Per Wissem sicuramente lo sarebbe stato.
Ecco, un pensiero ‘laterale’, ripercorrendo l’intera sua vicenda, da quando ha messo piede nel nostro paese, come non pensare che alla generosità (per carità sacrosanta) di cui siamo capaci di questi tempi fa da contrappunto la rigida graduatoria che abbiamo così chiara, a proposito dei beneficiari della nostra strabica accoglienza.
Scritto per Forum salute mentale