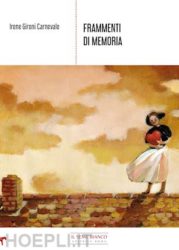“Le storie come le mie ricominciano sempre. Prendete un ragazzino e destinatelo alla povertà. Poi speditelo lontano da sua madre, in un posto dove non vuole stare e, se disobbedisce, punitelo severamente. Fategli anche subire qualche molestia dai preti. Quando diventa grande, mostrategli che polizia e carabinieri sono lì per fregarlo, in nome della legge e della sicurezza delle persone per bene. Cosa potete aspettarvi? Che vi dica grazie?……forse arriverà anche a pensare di lottare insieme agli altri e di potere vincere”. Un messaggio per tutti noi, che arriva dalle pagine di “Correvo pensando ad Angela”, biografia di Pasquale Abatangelo, “delinquente politicizzato”, come dice è sempre stato definito, protagonista di “una storia degli anni Settanta, che non è stata solo una storia individuale”, e che molto racconta di quegli anni…
Ma non è del libro, che pure molto merita, e dei conflitti sociali di quegli anni che voglio ora parlare, piuttosto del fatto che leggendo della sua vicenda personale, dalla nascita in una famiglia di sfollati, poveri, all’incamminarsi lungo un percorso che lo porta in collegio e poi nel carcere minorile, infine nel carcere “vero”, ho pensato a quanto questo percorso sia stato uguale a quello di tanti altri che poi dietro le mura di una prigione ho incontrato. E quanto anche per questi valgano le sue parole: “ero stato assegnato a quella fogna fin da ragazzino”. Infanzie e adolescenze segnate dalle difficoltà, dal collegio, dal carcere minorile.
Cosa che certo nulla vuole giustificare, ma indurre a riflettere e cercare spiegazioni certo sì. Ne abbiamo il dovere. Anche, e soprattutto, per chi a quel marchio di “delinquente” è rimasto inchiodato, delinquente senza aggettivi, ché il riscatto sembra lontano, se nessuno sembra voler riconoscere percorsi personali che nell’ombra delle mura di un carcere pur sono stati faticosamente avviati.
Perché percorsi altri dovrebbero nascere molto prima di finire in un collegio, o in un carcere minorile.
Guardandosi intorno… quante possibili “storie che ricominciano sempre” nelle strade delle nostre città… basta guardare le statistiche sulla povertà, o anche solo i numeri dell’abbandono scolastico, in Italia fra i più alti d’Europa, “grazie” alle regioni del Sud. E non sarà un caso che nelle nostre prigioni, da un estremo all’altro della penisola, sempre è eco di voci del Sud…
Non mi imbarco in analisi d’ordine sociologico ed economico, che oltretutto, difronte a numeri e ragionamenti di micro o macroeconomia, noi “non addetti” si fa presto a dare una scrollata di spalle e… ci pensi la politica. Ma c’è un piano sul quale siamo tutti coinvolti, e riguarda il nostro atteggiamento nei confronti di chi sappiamo ai margini e lì pensiamo in fondo in fondo debba per sempre restare inchiodato.
Lo ha raccontato bene in un suo libro Carla Melazzini, che con Cesare Moreno aveva fondato l’associazione “Maestri di strada”, che tanti ragazzi di Napoli e dintorni ha seguito e cercato di avviare a un futuro migliore di quello a cui sembravano destinati.
“Insegnare al principe di Danimarca”, il libro. Si parla, fra gli altri, di un ragazzino la cui madre aveva lasciato la famiglia per fuggire insieme a un uomo di altra “famiglia” e il cui cuore era segnato dal dolore, soffocato dal desiderio di vendicare in qualche modo il padre, di punire chi l’aveva così tradito e oltraggiato.
Beh, pensateci un po’: non è lo stesso impulso che muove il più celebre Amleto? Il principe di Danimarca che, conosciuta la verità sull’uccisione del padre, del tradimento dello zio che ne usurpa il trono e ne sposa la Regina, decide di vendicarlo.
Eppure… Amleto, protagonista di tanta letteratura, è diventato uno dei nostri più amati “eroi”, mentre siamo tutti pronti a giudicare male e respingere quel ragazzino nel nulla della sua periferia, nella confusione suo smarrimento.
Penso che questo libro, queste storie di ragazzi che senza i “Maestri di strada” sulla strada sarebbero rimasti, condannati anche da noi alle dinamiche dei loro difficili mondi, mi ha insegnato tanto, a proposito del riflettere e cercare di capire contesti.
Carla Melazzini non c’è più. Rimane il bel progetto nato per prendersi cura dei ragazzi delle periferie, e delle periferie delle loro anime. Ed è sicuramente quello che, pur fra tante difficoltà, e per quanto possibile, è stato fatto a Napoli e dintorni.
Una delle tante cose che bisognerebbe fare ovunque ci sia il rischio che “storie come le mie ricominciano sempre”.
scritto per Voci di dentro
Principi di Danimarca… “Ero stato assegnato a quella fogna fin da ragazzino”
Il grande cuore di Pietro Tartamella
E
sarò io a svegliare
i passeri
domani
conducendo un canto
ai loro nidi.
La nebbia
sonnolenta
tra i rami li vedrà
alla primaluce
volare a festa
col mio pane.
Un pensiero, con i suoi dolcissimi versi, a Pietro Tartamella, che all’alba di sabato se ne è andato. Se ne è andato un poeta che a tanti ha insegnato, instancabile, l’arte dell’ospitalità, della condivisione, delle parole dell’accoglienza e della poesia da dischiudere al mondo. E di quante persone come lui ci sarebbe bisogno per cambiarlo, questo mondo, viene da pensare proprio oggi che tuona la guerra con le sue parole di respingimenti e morte.
Pietro… (ne abbiamo parlato, in queste pagine) che la sua vita di artista di strada a un certo punto ha trasferito nel casolare di Borgata Madonna della Rovere, Cascina Macondo, diventato il fulcro di infinite attività, luogo di incontro e di continuo “pellegrinaggio” di amici che ad ogni suo invito, intorno ai suoi progetti, lì si sono radunati arrivati da ogni dove.
Anni fa l’avevo cercato proprio per raccontare alla radio la storia, che tanto mi aveva incuriosito, di questa sua, sua e della moglie Anna Maria, Cascina Macondo, affascinata dall’immagine che ne è il simbolo: un bel veliero, che ha le vele di foglie e naviga su un mare di sassi, in viaggio solcando i mari, per ritrovare il filo delle parole… e sempre intorno alle parole girano le mille attività della Cascina. Era impossibile non lasciarsi incantare e travolgere dalle sue iniziative e dalle sue potenti affabulazioni. Che spesso si traducevano in libri.
Voglio ricordarlo, Pietro, con uno dei primi libri che mi aveva mandato, testimonianza del suo grande impegno anche nelle carceri: “La stretta di mano e il cioccolatino”, in qualche modo resoconto di un progetto che ha coinvolto, fra Belgio, Italia, Polonia, Serbia, Grecia, dodici prigioni con circa 200 detenuti, impegnati in percorsi didattici, laboratori creativi e tante altre iniziative. E’ stato come un fiume lo scorrere di queste pagine, un’antologia di diari, riflessioni, racconti, poesie, haiku. Il racconto dei mille giorni di un progetto nato per portare scrittura ed arti nelle carceri. Ma soprattutto per portarne fuori, dalle carceri, scrittura e arti.
Coerente con il suo impegno, che è “semplicemente”, mi spiegò un giorno Pietro, tirare fuori il bello che è già dentro le persone.
Aprendo una pagina a caso, de “La stretta di mano e il cioccolatino”, ecco, un po’ del “bello” tirato fuori dall’anima di F.:
Viaggia la musica / come la pittura / le cicogne / gli emigranti / come le notizie / dei giornali / strappate ai passanti / dal vento / come le notizie /che invecchieranno / immediatamente / nelle pattumiere del tempo / … / ma l’amore della musica conduce sempre alla musica dell’amore / e quando la musica è quella della sofferenza…
Pensando al suo sogno di una società “solidalista”, come scriveva, a conferma di quello che da tempo penso anch’io: che c’è un’Italia molto migliore della rappresentazione che mediamente se ne dà e di chi la rappresenta.
E mi piace ancora pensarlo seduto sotto l’ombra del grande rovere, a pochi passi dalla Cascina. Da poco si era tutti come prigionieri della pandemia, e Pietro Tartamella, lì seduto al centro di un’ideale prigione senza pareti, ha invitato amici e conoscenti a sfilare davanti a lui per raccontare di viaggi, di tutti i modi possibili di viaggiare, che è anche solo attraversare una strada, perdersi in un sogno… Sono fiorite tante storie, frammenti di esistenze raccolte nelle pieghe del nostro andare. Che tutte, trattenute come ai limiti di un cerchio dalla forza centripeta del suo stare, vi si muovevano intorno come in una danza… Una danza felice, nonostante tutto.
Ecco, mi piace pensarlo ancora lì, a dettare il ritmo di quella danza. Ricordando un suo appunto…
Per tutta la vita hai sognato e lottato
Per lasciare una traccia di te nel cuore della gente
E ti accorgi alla fine di quanta gente
Ha lasciato di sé una traccia nel tuo cuore.
Parole che tanto dicono di lui e del suo grande accogliente cuore…
scritto per ultimavoce.it
Dal pianeta degli umani…
“Dal pianeta degli umani”
Appiattiti nell’istante in cui vengono pronunciati nello schermo a due dimensioni, il tempo e le cose vanno via in fretta. Le notizie dopo un’ora sono già morte.
Eppure, ogni nostra azione, ogni nostro sentire, ogni paesaggio, ogni strada, ogni pietra… hanno dentro di sé la storia che ci ha partoriti, che ha costruito, nel bene e nel male, il nostro presente, anche se noi, quella storia, non la vediamo più. Noi che non riusciamo a vedere neanche presenze vicinissime che appena un soffio prima ci sono passate accanto, pur lasciando tracce, che neppure vogliamo leggere. C’era una volta, e chissà, forse c’è ancora adesso…
Ripesco questo appunto/riflessione sulla fiaba mentre ancora riscorrono e risuonano nella mente le spiazzanti immagini e le potenti sonorità del lungometraggio di Giovanni Cioni, “Dal pianeta degli umani”. Appena visto in un cinema romano, il Troisi, per la cronaca.
“C’era una volta, a quei tempi, ai nostri tempi. È una fiaba, non è mai successo. È una storia vera”…
Ti spiazza fin dall’inizio questo film, che vuole essere una fiaba, della fiaba sceglie in qualche modo il linguaggio, entrando il regista, con la sua voce, a narrare. Ed è voce cui fa da contrappunto un coro di rane, che nella narrazione entrano, perché… “le rane sono invisibili e sono ovunque. Animali di passaggio tra la vita e la morte, fra l’acqua e la terra. Testimoni della storia, raccontano la fiaba del mondo”, spiega Giovanni Cioni.
Qui si testimonia di una storia tutta racchiusa in un breve tratto di terra, vicino Ventimiglia, al confine con la Francia. Confine dove passano i migranti dell’oggi, e dove c’è un sentiero nascosto, “il sentiero della morte” lo chiamano, e potete immaginare… Solo tracce di questi migranti, come fossero già fantasmi. Quei fantasmi che noi vogliamo respinti nel nulla…
Fra la bellezza del mare e l’umore nero di quel sentiero, c’è, in alto sulla costa, una villa, villa Grimaldi, che di un altro “sconfinamento”, si racconta, è stata teatro. Negli anni Venti del ‘900 vi ha abitato e operato un medico russo, di origine ebraica, Voronoff, a quei tempi diventato molto famoso per i suoi studi sul ringiovanimento. Trapiantava sugli uomini testicoli di scimmie. E le urla dei poveri animali si dice arrivassero fino al mare.
E i fantasmi di oggi si intrecciano con i fantasmi di ieri. Come non sentire, seguendo le tracce del sentiero della morte, il crepitare sommesso delle foglie sotto i passi in fuga… e a guardare quel che resta delle gabbie delle scimmie, come non sentirne ancora lo strazio…
L’idea del confine, dunque, che non è solo confine dello spazio o del tempo, ma è anche confine dell’umano. Una riflessione sulla vita e sulla morte, sul sogno di sconfiggerla, questa morte, con tutte le aberrazioni che questo ha comportato e ancora (non lo vediamo?) comporta. Una riflessione sul vero e sul non vero. Se è vero solo quello che vediamo. “C’era una volta, a quei tempi, ai nostri tempi. È una fiaba, non è mai successo. È una storia vera”…
Il racconto delle voci e delle immagini sconfina continuamente dall’oggi all’ieri e dall’ieri all’oggi. Dalla voce di un migrante alla narrazione di un cronista del Ventennio, dal documento “storico” (terribile quello delle scimmie vittime degli esperimenti di Voronoff, sbeffeggiante quello su Mussolini, tenerissimo quello che ci porta sulle spiagge delle vacanze al mare…) a quel che rimane del giardino della villa di Voronoff, dall’azzurro del cielo sulla costa al bianco e nero di vecchi film. E tutto lega il mare, e la voce delle rane, che cantano nelle cisterne dove Cioni le ha incontrate (e registrato il canto), e la voce del regista che a tratti con quella del mare si confonde.
Insomma, una bella “scossa”. Spiazza davvero questo lungometraggio di Giovanni Cioni, decisamente fuori dal comune. Ed è difficile, credo, uscirne indenni.
Ho visto altri suoi lavori. “Non è sogno”, film nato nel laboratorio teatrale Nuvole, del carcere di Capanne, a Perugia, dove tutto gira intorno al conflitto fra la libertà e il destino, ma anche fra la verità e l’apparenza, fra la vita e il sogno… “Dal ritorno”, il ritorno senza fine di Ivano, soldato italiano in Grecia, nel ’43, prigioniero dei Tedeschi, deportato a Mauthausen, dove fu addetto ai forni crematori. Forme e formule, sempre diverse, che tutte indagano l’Uomo.
Ripensando a quest’ultimo lavoro, sentendo ancora battere nella testa i toni, a tratti quasi un canto, della sua voce narrante… la verità è che Giovanni Cioni è un poeta… e come tutti i poeti da quello che vede si lascia emozionare, sconvolgere, rapire, portare, anche nella scrittura cinematografica, dove le emozioni lo portano.
“Dal pianeta degli umani”, che finalmente comincia a circolare, ha vinto il Festival dei popoli del 2021, ed è ora in lizza per il David di Donatello, nella rosa dei dieci selezionati. In gara con registi del calibro di Tornatore e Bellocchio.
Se volete avere anche voi una “scossa”, andate a vederlo. Cioni riesce benissimo a farci sprofondare nella dimensione che le fiabe, da sempre nate da una profondità che nella nostra corsa quotidiana sembriamo dimenticare, sanno da sempre leggere. E arrendetevi a questa sua fiaba.
scritto per ultimavoce.it
Frammenti di memoria
Un libro può essere molte cose. Un romanzo, una biografia, un saggio, una raccolta di racconti, una fiaba. E questo che genere di libro è? Come molte cose della mia vita non è definibile con precisione…”.
E’ vero, me lo sono chiesta anch’io all’inizio della lettura. Cosa sono questi “Frammenti di memoria”, che Irene, Irene Gironi Carnevale, vuole condividere con noi…
La spiegazione ce la dà proprio lei nel retro della copertina: piccole storie di vita quotidiana pescati dalla memoria del passato, “con l’intento di raccontare, come si potrebbe fare fra amici davanti ad un caffè o sul divano in una sera d’inverno…”.
E va bene, ma quando il frammento di un racconto molto personale (fra una Prima comunione e un pranzo di Natale, una querelle su una data di nascita e una gita al mare), destinato agli amici, fa “il salto” per diventare altro… mi sono chiesta come cercando, un po’ dubbiosa un po’ curiosa.
Poi frammento dopo frammento si è composto un mondo… Già suggerito, è vero, da quell’ “Avevamo un sogno” del primo frammento. Avevamo un sogno e magari più d’uno “ma quello principale era cambiare il mondo, anche se era solo il nostro piccolo mondo”.
Diciamo pure che in qualche modo era anche il mio mondo, una questione, dunque, diciamo pure generazionale… fatto di gonne a fiori e sigarette fumate di nascosto, un rifugio da dividere con una folla di amici/fidanzati/amanti, pochissimi, o nulli, soldi, e la meraviglia che pure i momenti migliori sono stati proprio quelli, ché non era la disponibilità di denaro, e mai hai imparato lo sarebbe stata, ad arricchirti la vita…
Ricordi, con quel pizzico di nostalgia per la ragazza di allora (e che eri anche tu) che ti morde l’anima. Ma non è solo questo.
Frammento dopo frammento di questo narrare, a volte gioioso, a volte triste, a volte ironico… è un mondo “pieno” di donna che si compone, con i suoi sogni, le cose belle e brutte che nella vita vengono incontro, le gioie, i dolori, le persone amate, quelle che ti amano e poi vanno via, le famiglie complicate, che si compongono e si sciolgono, i figli, l’incontro con la disabilità, il coraggio, tanto coraggio… mentre un gabbiano solca il cielo sulla costa campana dove tutto ha inizio e tanta acqua scorre sotto i ponti della città dove la vita ti ha portata…
E il ritratto di donna che ne nasce fa pensare a persona che molto ha da insegnare e da cui, perché no, prendere qualche appunto. Tanto per cominciare, a proposito del fatto che ogni frammento dell’esistenza è tutta da vivere. E “domani è un altro giorno” non è solo la celebre battuta di un film che pure abbiamo amato (e continuiamo ad amare nonostante i sussulti del politicamente corretto che ce lo vorrebbero oscurare). E poi le riflessioni sull’essere donna, sull’essersi “ritagliata uno spazio di assoluta normalità, modellata sulla diversità che ti riguarda”, pur nel suo essere “contro” (contro le domeniche, le feste comandate, le ritualità ipocrite…). E poi, e poi…
Comincia e finisce con un sogno, questa raccolta di frammenti. “Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna solo di notte”… Chi lo ha detto? Non ricordo. Ma, arrivata all’ultima pagina, è il primo pensiero che mi è venuto in mente.
Va beh, ho detto che quello che, leggendo leggendo, mi ha fatto sentire in sintonia con Irene non è solo una questione di comunanza generazionale, ed è vero.
Però, però… alla fine è stato tutt’uno chiudere il libro e andare a ripescare una musica che non sentivo da un po’, anche perché molto mi strugge riascoltare. Neanche a dirlo, Guccini, e precisamente, indovinate un po’, Radici…
La casa sul confine dei ricordi… la stessa sempre, come tu la sai…
E tu ricerchi là le tue radici… Se vuoi capire l’anima che hai…
Mentre in fondo in fondo all’anima rimane il sospiro rappreso di un tempo, al pensiero che… un pazzo si è lanciato contro al treno… un pazzo si è lanciato contro al treno…
Ché questo non l’ho mai dimenticato… che gli eroi sono tutti giovani e belli… e sono sicura ancora oggi come me si commuove Irene, al ricordo dei visi e delle voci che intorno a quel canto, tante sere, s’incontravano…
Per Amal…
Amal ha 17 anni e una grave malattia neuromuscolare, che gli rende molto difficile muovere alcuni muscoli del corpo. Ma non è tutto, Amal da un anno è in carcere senza alcun tipo di accusa formale. Così Amal, giovanissimo e malato è costretto a una ‘detenzione amministrativa’ dietro le sbarre. Il papà, dopo una delle sue numerose visite al figlio in carcere, ha detto: “Non poteva muovere le labbra, non poteva muovere gli occhi, non poteva sorridere, questi sono i sintomi della sua malattia e siamo molto preoccupati”… L’unica speranza di Amal è che si crei abbastanza pressione pubblica e internazionale attorno al suo caso da indurre il governo israeliano a rilasciarlo
Lanciato tramite Change.org, circola da qualche giorno in rete questo appello.
Storia di Amal Nakhleh, accusato dalle autorità israeliane di aver lanciato pietre contro i soldati. Amal cui, leggo nell’appello, un anno fa è stato asportato un tumore ai polmoni. I suoi genitori temono che durante la detenzione possa morire.
Leggo, ancora, gli accorati appelli per la sua liberazione, dell’agenzia dell’Onu che si occupa dei rifugiati palestinesi, l’UNRWA, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, dell’Unicef… Si chiede l’immediato rilascio per due motivi: le sue gravissime condizioni mediche e perché minorenne. Eppure, alcuni giorni fa la sua detenzione è stata prorogata fino a metà maggio, senza alcun processo…
Guardando il volto di Amal, che sembra poco più che un bambino. Diventa oggi il volto di tutti i minori palestinesi chiusi nelle carceri israeliane. Che sono storie cui si fa fatica a pensare.
Secondo i dati raccolti dalle organizzazioni che si occupano della condizione dei Palestinesi, ogni anno in Israele vengono processati tra i 500 e i 700 minori. E sono processi che si svolgono nei tribunali militari, perché nei Territori Occupati della Cisgiordania si applica la legge di guerra, la giurisdizione è dunque delle corti militari. Secondo le denunce di molti osservatori, ragazzi palestinesi subiscono spesso arresti e detenzioni arbitrari. L’accusa più comune è quella di lancio di pietre. Un reato per il quale è prevista una pena che può arrivare fino a 20 anni di carcere. E se attualmente sono circa 5mila i prigionieri politici nelle carceri israeliane, fra questi anche donne e minori, secondo i dati più recenti quasi 500 palestinesi sono detenuti senza aver mai subito un processo, e fra loro 6 minorenni. Detenzioni “amministrative”, come quella di Amal, che possono protrarsi a tempo indeterminato.
Condizione terribile, quella dei minori palestinesi detenuti da Israele. A tratti arrivano notizie di violenze, torture, anche… Una condizione terribile che ben ha descritto l’ultimo rapporto di Save the Children, nell’autunno del 2020. “La condizione dei minori palestinesi nelle carceri israeliane è allarmante. Sono infatti costretti a subire trattamenti disumani come percosse, perquisizioni corporali, abusi psicologici, settimane in isolamento, e viene loro negato l’accesso a un avvocato durante gli interrogatori”. Un rapporto dal titolo che già molto dice: “Senza difesa”. E, si sottolinea, questi minori sono gli unici al mondo che vengono sistematicamente perseguiti attraverso un sistema giudiziario militare invece che civile, con tutto quel che comporta in termini di assenza di tutela dei diritti.
E tanto ancora ci sarebbe da dire.
Ma solo una riflessione…
Che stridore, guardare il volto bambino di Amal, pensarlo in carcere, pensare alle sue condizioni di salute, leggere degli appelli, finora caduti nel vuoto, per la sua liberazione proprio in questi giorni, a ridosso della Giornata della Memoria.
Tragico destino quello dei Palestinesi. Essere vittime delle vittime. Come scrisse, toccando uno dei nodi profondi della questione palestinese, Edward Said.
Visitando Gerusalemme, salendo sulla Collina del Ricordo, allo Yad Vashem, il memoriale dei morti della Shoa, degli uomini, delle donne, dei bambini… No, viene da pensare, se potessero vedere, se potessero sentire, non sarebbero affatto fieri di tutto questo altro inumano dolore. “Non in mio nome…” forse, sussurra, qualcuno…
scritto per Ultimavoce
L’altra Shoa
Operazione T4, il nome del progetto di eliminazione sistematica di malati di mente, portatori di handicap, persone affette da malattie genetiche… Uno sterminio del quale poco si parla, quello delle persone disabili, vittime troppo spesso dimenticate, come i rom, gli omosessuali, i testimoni di Geova… Eppure, tutto è cominciato ancora lì, nella Germania nazista.
Frugando e cercando per saperne qualcosa di più, mi sono imbattuta anni fa nel sito documentatissimo, che purtroppo ora vedo non più attivo, dell’associazione Olokaustus, e con l’allora suo presidente, lo storico Giovanni De Martis.
Riprendendo dagli appunti di quella conversazione, che molto mi ha insegnato in proposito…
Intanto, a leggere lo sterminio dei disabili soprattutto come preludio dell’Olocausto. Un preludio cronologico, nel senso che lo sterminio dei disabili tedeschi iniziò a essere programmato appena dopo l’arrivo al potere dei nazisti, verso la metà degli anni ’30, e “tecnico-preparatorio” di quello che sarebbe in seguito accaduto. Perché fu nelle cliniche psichiatriche che vennero sperimentate le prime camere a gas.
Si sperimentarono anche altri metodi, fra cui le iniezioni con sostanze letali, che però non si dimostrarono molto “pratiche” (furono comunque utilizzate dai medici nei campi di concentramento per sopprimere le loro cavie umane).
Insomma, l’operazione T4 “risolse” il principale problema delle gerarchie naziste: come uccidere in fretta il maggior numero di persone possibile.
Quello che mi colpì molto del racconto del professor De Martis è stato il grande ruolo avuto dalla classe medica, per l’iniziale rapporto di fiducia con le famiglie dei disabili, dei malati, e per l’uso che è stato fatto, di questa fiducia…
“Pensate… il nostro medico di base ci dice che sono in corso esperimenti che possono guarire in maniera definitiva, facendo accendere così grandi speranze, da parte di una persona insospettabile… Questo intervento dei medici di base ha permesso prima di avviare l’operazione T4, poi condurla nei nosocomi, nelle cliniche psichiatriche”.
Aveva parlato, il professor de Martis, di un doppio binario di moralità che ha reso possibile tutto questo. “Un doppio binario che esisteva anche prima dei nazisti e che esiste ancora. Durante la Prima guerra mondiale noi abbiamo dati che ci dicono che la mortalità nei manicomi era triplicata rispetto alla mortalità prima dello scoppio del conflitto, e gli stessi psichiatri riconoscono di aver ridotto le razioni alimentari per via dell’idea che nei momenti di crisi bisogna far vivere il migliore rispetto al peggiore. Un’idea che è ancora molto diffusa. Soprattutto nei momenti di crisi economica molte voci si alzano dubitando dell’importanza di aiutare i più deboli”.
I malati, gli improduttivi, i nati deformi erano da denunciare… “Ma tutto questo è stato possibile anche per il sentire generale della gente normale che in qualche modo ha assimilato e accettato la propaganda sulle idee e le teorie eugenetiche”.
Propaganda nelle scuole, nei cinema, documentari… Propaganda di grande forza, basata su affermazioni molto semplici. Si spiegava ad esempio quanto costava mantenere un disabile e cosa si poteva fare con quel denaro. “Sono argomenti che nei momenti di grande crisi possono attecchire nella mente di chi si trova in difficoltà. Funziona sempre”.
Già, funziona sempre…
Nella prima fase del T4 ufficiale morirono circa 96mila persone, ma dalle ricerche fatte si è scoperto che in alcune cliniche si continuò ad uccidere anche dopo la fine della guerra. Gli studiosi tedeschi parlano probabilmente di altre 260/300mila persone disabili uccise.
Ma l’eliminazione del debole, del malato, del disabile, è cosa che affonda le radici nella nostra storia lontana…
Viene in mente quanto letto in un libro di Carlo Lepri, che è psicologo e formatore, (“Viaggiatori inattesi”), che cita fra l’altro il Convito di Platone: “E’ brutto per un medico il voler tentare di curare ciò che per natura è cattivo”. Per spiegare che la necessità è quella di associare la disabilità con un errore della natura e gli uomini vi devono porre rimedio.
Propone, Lepri, la sintesi più efficace in quest’immagine dalle epistole di Seneca: “Noi uccidiamo i cani idrofobi, abbattiamo il bue furioso, distruggiamo la progenie snaturata, e affoghiamo anche i bambini che al momento della nascita siano deboli o anormali… E aggiunge che non è la rabbia ma la ragione che separa il nocivo dal sano, per farci intendere che questa posizione non è dettata solo da posizione emotiva, ma è un fatto razionale”.
Tutto questo motivato dalla difficoltà che in tutta la sua storia l’umanità ha incontrato nel fare i conti con la diversità… da Sparta per arrivare alle teorie eugenetiche, allo scritto della fine degli anni ‘30 di un famoso biologo tedesco che: “ogni contadino sa che se uccidesse i migliori esemplari dei propri animali domestici e continuasse a far riprodurre gli esemplari più scadenti, le sue razze d’allevamento andrebbero incontro a una irrimediabile degenerazione”. Duemila anni dopo Seneca, rimane il tentativo di associare la diversità con l’animale malato, con l’errore della natura. Da eliminare.
Insomma, la storia, quando si ricorda delle persone con disabilità, sembra lo faccia spesso più che altro per proporne l’eliminazione, mentre i disabili sono rimasti a lungo un popolo silenzioso. Non è da molto che hanno iniziato a scriverla loro, la loro storia, e questo sta facendo fare passi avanti…
E ben venga oggi l’iniziativa della Biblioteca nazionale centrale di Roma. “Prima di tutto vennero a prendere i disabili”, un incontro dedicato alle migliaia di persone uccise e torturate in nome dell’eugenetica nazista. Perché il rischio, oggi, rimane un’idea di efficienza, di produttività… cui la civiltà di cui tanto ci vantiamo ancora sembra non fare sufficientemente argine.
scritto per ultimavoce.it
La terra è di chi la canta
Luisu infila grosse calze di lana grezza, e la cenere del camino la senti che ancora è calda… il suo sguardo scruta il buio di un ripostiglio… si allunga sul percorso dei sentieri, si intreccia fra i rami di un albero di limone… le sue mani intrecciano paglia, tagliano rami secchi… calcano la terra dove ha appena piantato tuberi… in un momento di riposo il suo sguardo si solleva a guardare il cielo da un letto di fiori sottili… il panorama intorno sono profili di clivi, e dossi e ancora sentieri fra gli alberi… gli oggetti intorno sono arnesi che lavorano la terra, e li immagini accompagnati da gesti antichi… sulla sua mensa anche il pane sembra avere il sapore buono della terra, come le pietre del vecchio casolare umido d’edera.
Luisu, Luigino, viene incontro dalle pagine del lavoro fotografico di Pietro Basoccu, medico-pediatra-fotografo d’Ogliastra (ne parlo a tratti, sempre rapita dal mondo, rigorosamente in bianco e nero, che racconta… https://www.ultimavoce.it/sotto-il-cielo-d-ogliastra-uno-sguardo-sulluomo/ ) a raccontare questa volta (“Luisu”, Soter Editrice) quel legame particolarissimo che ha l’uomo con la terra.
“Il rapporto stretto con la terra è una caratteristica di ogni essere umano a prescindere dall’epoca in cui vive… Per alcuni uomini tutta la vita è votata alla campagna, all’agricoltura. Dalla terra traggono tutto o in parte il necessario per vivere, la terra è rifugio e conforto”, spiega Basoccu, che apre lo sguardo su “uomini intrisi di cultura contadina che vivono e conoscono il ritmo della terra e delle stagioni”.
Ma mentre guardo, e sfoglio, e sento l’odore del fogliame, vedo comparire come in filigrana, e non riesco ad evitare che vi si sovrappongano, le immagini del mondo contadino che mi ha svelato Mario Trudu.
E mi perdoni Luisu se accosto la sua immagine a quella di un ergastolano. Ex ergastolano, ché Mario, due condanne per sequestro di persona (del primo si è sempre dichiarato innocente), non c’è più. Portato via da una morte cattiva e ingiusta dopo 40 anni di detenzione, e vi risparmio dettagli. E perdonatemi, ma imparando a cogliere, seguendo di prigione in prigione gli ultimi dieci anni della vita prigioniera di Mario Trudu, i moti profondi del suo animo, mi sono convinta che dopo una pena infinita, e senza spiragli, non si è più colpevoli ma vittime di uno Stato che solo cerca vendetta.
Guardo Luisu e penso a Mario che mi spiegava come ciò che gli ha permesso di resistere tanto tempo dentro quattro mura (e che mura!) è stato il ricordo della sua terra. Della terra, della vita fra i monti, fra i boschi… e sempre, quando ne parlava, gli si illuminavano gli occhi. “Sin da bambino ero attratto dalla campagna. Avrei voluto rimanervi giorno e notte, niente mi attirava più dei boschi, dei campi, dei fiumi, degli animali”, scriveva.
Guardo, nelle foto di Basoccu, le mani di Luisu, e rivedo quelle di Mario… solide, forti, mani di pastore che tutto sapevano fare.
Guardo il ritratto di grappoli di cipolle, il pane, i semi sulle tavole… e penso alla cantina della casa di cui Mario mi raccontava e “chiudendo gli occhi ancora ne sento l’odore, sento il sapore di tutto quel ben di dio”.
“Eroi della zappa” definiva la sua gente. Rendendo omaggio alla memoria dei suoi tanti ‘Thiu.
Non potete immaginare quanta gioia ha espresso parlando dell’albero che riusciva a vedere dalla sua nuova cella quando fu trasferito nel carcere di San Gimignano… “Mio Dio!.. mi aggrappai con le mani alle sbarre, vi appoggiai la testa, come se avessi paura che ammirare tanta bellezza mi facesse mancare le forze”. Dopo 35 anni che le sue finestre affacciavano solo su mura, restò aggrappato a quelle sbarre tutta la notte…
Molto da lui ho imparato del rapporto dell’uomo con la terra, dell’immensa forza che può nascere da questo legame quando profondo come il suo, che è legame ininterrotto con la propria essenza profonda. E le immagini di Pietro Basoccu, attraverso il protagonista di questo suo racconto, me lo riportano tutto.
Guardo Luisu sorridere sulla soglia del pollaio e penso a quando Mario mi confidò che sognava ancora di poter finire i suoi giorni ritornando alla terra, ai suoi boschi, accanto ai suoi animali.
E’ vero, ciò che in quarant’anni di non vita lo ha tenuto in vita è stato il ricordo della sua terra. Che non è solo ricordare, come chiunque di noi può immaginare e fare, è qualcosa di più. E’ immaginare di esser altrove con tanta forza da avere anche la sensazione fisica di essere in quell’altrove. E questa cosa, questa forza d’attrazione immensa, questo richiamo che dalla sua terra arrivava, l’ho capita la prima volta che in primavera, in Ogliastra, ho visto i campi di asfodelo fioriti…
La terra, si dice, è di chi la canta. Parlandone come in un canto, anche in quello che è diventato poi un libro (“Cent’anni di memoria”) Mario ha dichiarato la sua appartenenza alla terra e l’appartenenza della terra a lui.
Ed è la stessa indissolubile appartenenza che Basoccu ci racconta con queste sue immagini, come dichiara il sorriso di Luisu, che ammicca a un mondo di cui conosce il pulsare segreto.
Ha ragione Pietro Basoccu, che ancora una volta ci regala un densissimo sguardo sull’uomo: “Sono uomini intrisi di cultura contadina. Non c’è distinzione fra passato presente e futuro. Non è che un’illusione, per quanto tenace. Anche Laerte, re contadino, insegna al figlio ad amare la terra e a conoscerne la ciclicità e sarà questa comune anima contadina a permettergli di capire che quello che gli si era presentato davanti era il figlio che mancava da vent’anni”. Pensando a Omero…
E non sarà un caso che Omero, di cui conosceva a memoria i versi, era il cantore preferito di Mario. E mi chiedo quali versi ha nel cuore Luisu, che con pennellate di scatti Basoccu ha con la sua terra cantato.
scritto per Ultimavoce.it
C’è un angelo sopra a Salerno…
Salerno chiama Berlino… le vie del cielo sono infinite… e guardate Daniela Morandini cosa sa leggervi…
“C’è un angelo sopra a Salerno che mi riporta ad un suo omologo tedesco, nato dall’obiettivo di Wim Wenders. Si chiama Damiel, dorme sulla Siegessaule, la Colonna della Vittoria di Berlino. Angelo laico col cappotto nero, studia in biblioteca, si commuove sulla Potsdamer Platz, prende l’autobus sul Ku’damm, si innamora dell’acrobata di un circo. Attraversa il Muro come se non ci fosse, perché, in quegli anni, quel Muro spaccava ancora l’Occidente.
E c’è un altro angelo nato a Salerno, disegnato su un muro che resiste vicino ad un arco. Non so come si chiami. Neanche la sua strada lo sa: solo “Vicolo dell’Angelo” c’è scritto sulla targa.
E’ un cherubino col costume da bagno verde, un po’ barocco, un po’ pagano e un po’ guaglione. Non dorme mai e si spinge tra le inferriate di una finestrella dipinta.
E visto che le luci sono ancora accese, magari è Benino, il pastore che dorme nel presepe, e che si è svegliato per viaggiare nella conoscenza. In ogni caso, il putto di Salerno si sporge sempre di più e per non precipitare infila un piede nella rete di un pescatore e lancia una barchetta di carta:
…tutto è allumato cumm’a miezjurno… c’è scritto.
Allora mi tornano in mente le parole dell’ angelo tedesco:
Quando il bambino era bambino, se ne andava
a braccia appese,
voleva che il ruscello fosse
un fiume
il fiume un torrente,
e questa pozza il mare.
Colori diversi, stesso cielo. Chissà dove si sono incontrati quei due…”
Daniela Morandini
La foto del murales di via dell’Angelo è di Isaura Fertitta