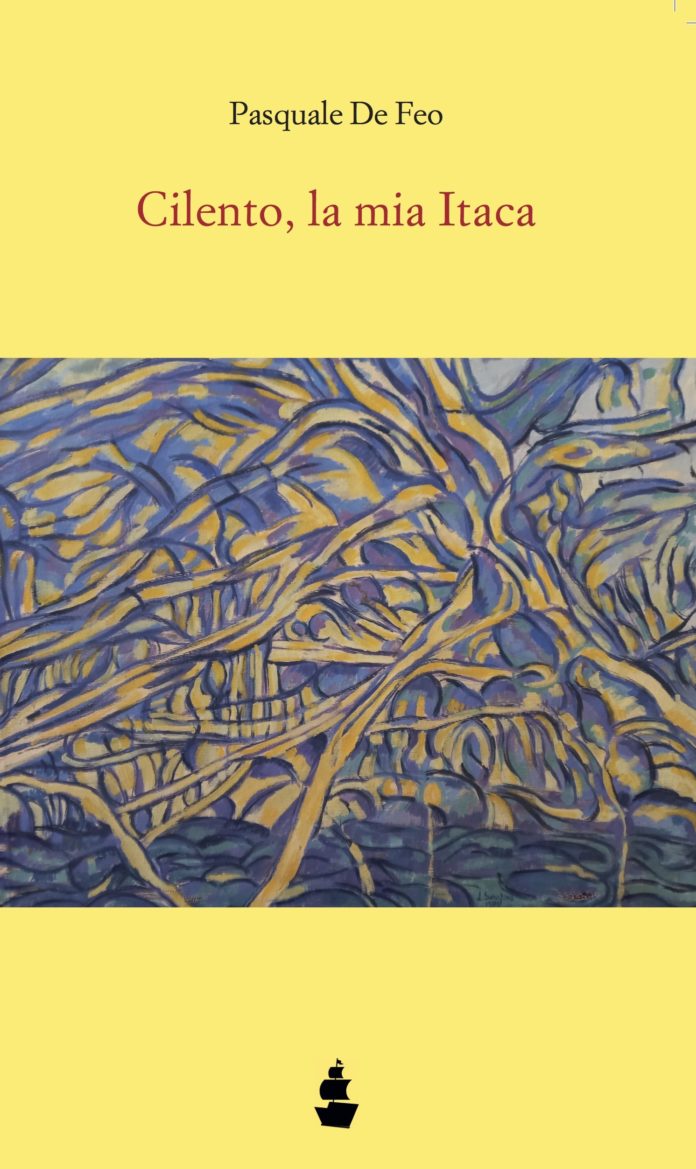Gli alberi sono angeli feriti. Parola del “Filosofo Ignoto”, eco di Guido Ceronetti in una delle sue più belle e doloranti raccolte di versi e pensieri, le Ballate dell’Angelo Ferito, appunto. Oggi che l’uomo non vede più gli angeli…
E una strage di angeli mi ha sorpresa ferendomi agli occhi questa mattina mentre mi affaccio sulla breve traversa dietro casa…
E’ vero, era stato annunciato da sinistri stridori di sega, nei giorni scorsi. Tutta una mattina, e poi la mattina seguente ancora. Un lamento da brividi, da perforare il cervello e l’anima. Bloccata in casa dal covid proprio ne ho rimosso da me il pensiero. Ma poi…
La sorpresa, nella grigia luce di questo fine settimana, della strada decapitata della sua folta galleria d’oleandri…
E’ rimasta una teoria di braccia di rami troncati che a guardarli è davvero un pianto. Ah, vedo risparmiati due o tre alberelli che erano stati piantati lo scorso anno, che quelli troppo ingombro ancora non danno…
Certo, si dirà che erano malati, con quei fusti a tratti ritorti nei bozzi di quella sorta di tumore che avvinghia le piante costrette a respirare i malsani umori delle nostre città (ma nessuno si è mai occupato di curarli); certo si dirà che erano pericolosi, con qualche fusto inclinato a inseguire la luce che nella strada s’insinua di sghembo (ma nessuno, negli anni, ha mai pensato di potarli aiutandoli a raddrizzarsi); certo, e questo è sembrato forse davvero intollerabile (!?), troppa resina cadeva dalle piante sulle nostre lustre automobili. Una bella seccatura…
Certo, che volete che importi… un mucchietto di alberi decapitati di una strada secondaria. Alberi che nessuno sa più curare, potature che sono piuttosto capitozzature… Che significa, li avrete visti ovunque, tagli drastici dei tronchi e dei rami primari. Chi qualcosa ne sa da tempo denuncia questo sistema di “potatura”, sbrigativo e drastico, come una delle cause principali delle cattive condizioni in cui versano gli alberi di tante città, i nostri alberi “ornamentali”, che così crescono male, brutti, snaturati e senza difese…
Dimenticando, o volutamente ignorando, chi si occupa del nostro verde, quanto da tempo si sa a proposito della vita delle piante. Della loro architettura, della loro saggezza, della loro intelligenza. Di quanto siano consapevoli, le piante, di ciò che accade in loro e intorno a loro.
Le trattiamo malissimo, eppure quanto avremmo da imparare…
Leggevo proprio in questi giorni un interessantissimo articolo di Riccardo Venturi (da un vecchio numero di doppiozero), o meglio una sua conversazione con Emanuele Coccia, filosofo, autore fra l’altro de “La metafisica della mescolanza”…
Fra le tante cose ci ricorda che le piante sono gli unici esseri viventi “liberi dalla predazione animale”, che per vivere non hanno bisogno di uccidere altri esseri viventi. Le piante piuttosto permettono agli animali di vivere, anche con i loro prodotti di scarto, come l’ossigeno.
“Nelle piante è evidente che la vita è qualcosa che viene sempre da un altro vivente per andare verso un altro vivente… una metafisica della mescolanza che contiene un insegnamento profondo per il nostro modo di stare insieme…”.
E il modello “politico” diventa la foresta, se questa parola viene dal latino foris, “tutto quello che resta una volta che la città si è chiusa su di sé, l’insieme dei viventi esclusi da quella che viene considerata civiltà”. “Mentre la città si costituisce esiliando fuori da sé l’albero e la vita che esso rappresenta”.
E siamo ancora qui, dunque, a esiliare e soffocare la vita…
Guardando questi fantasmi di tronchi smozzicati e nudi di foglie dietro casa, come non sentire il lamento che invade il viale?
Canto, come di requiem, per angeli caduti. Che, nonostante nella caduta feriti, pure rimangono sulla terra. Rimangono, nonostante noi, per aiutarci a comunicare fra noi e non solo, ostinatamente cercando di tessere ponti impossibili fra il “diabolico” e il “simbolico”, per noi che gli angeli non riusciamo più a vederli, né a sentirli.
Certo, torneranno per come potranno le foglie, magari fiorirà, pure, quel che resta degli oleandri… che la vita della natura è più forte della violenza degli uomini…
Rimane oggi la mestizia, sotto il cielo grigio, di questo breve cimitero di tronchi spogli e un addio, per chissà quanto, all’esplosione di fioriture immense, traboccanti di feste di colori che ogni estate riempivano l’aria di gioia…
scritto per ultimavoce.it
angeli feriti….
Le buone mani…
“Certo potrebbe avere una goffaggine, zoppicare leggermente, ma chi se ne frega? Cosa vuoi che sia? Una vita è sempre un’addizione e la pelle il sangue e l’acqua di ogni corpo riempiono un vuoto, uno spazio altrimenti deserto. Non c’è fatica o sofferenza a sminuire l’ingombro di un amore”.
Ed è un amore che non può che pervadere ogni attimo della vita, quello che si catapulta nell’esistenza dei genitori di Matteo, che a pochi giorni dalla nascita viene colpito da emorragia cerebrale. Matteo viene ricoverato, operato, il rischio è l’idrocefalo… gli interventi si susseguono, ed “è un campo di battaglia, un’invenzione cubista, la testa di Matteo, opera di un scalpello impazzito”.
“In buone mani”, di Michele Greco (ed. Scalpendi), è il racconto dei giorni di quel lunghissimo ricovero, e di tutto quel che accade di stravolgente nella vita della famiglia del piccolo Matteo. Un diario in prima persona scritto da sguardo di padre.
Un racconto, minuto per minuto, senza respiro, dove i tempi sono dettati dalle ansie, dalle Tac, le diagnosi, le paure, l’improvvisa riorganizzazione dell’esistenza…
Un racconto senza respiro, come senza respiro sono stati i giorni per i genitori di Matteo. Le loro giornate accanto al lettino d’ospedale, a sussurrargli canzoni e scampoli di fiabe, ad accarezzarlo, a lievemente baciarlo. E a pendere dalle parole, dagli sguardi, dalle rassicurazioni dei medici, quando il chirurgo diventa per loro la persona più importante (“dopo Matteo, va da sé”), quando pure ci sono momenti che le parole “sollievo e speranza” diventano le più importanti del loro vocabolario, e “le ripetiamo ad alta voce perché acquisiscano materia e peso”.
Si legge tutto d’un fiato questo racconto, che non dà tregua. Come senza tregua sono stati quei giorni, fra l’ospedale e la casa muta di pianti. Fra l’altro anche alla ricerca di un equilibrio per l’altro figlio, Giovanni, che il fratellino, a casa, aspetta che torni.
Questo sguardo di padre sa allargarsi, carezzevole, anche su tutta la piccola comunità di bambini ricoverati e dei loro genitori, fra sale d’aspetto e corridoi fioriti di bambi e caprette, dove a unire è il dolore, “quasi una creatura viva nel viso dei bimbi e nei loro corpi costretti da aghi e tubicini”. E i legami che ne nascono, passando fra il regalo di una figurina di Madonna protettrice, un lutto e un sorriso, non si spezzeranno con le dimissioni di Matteo.
Tutto raccontato, minuto per minuto, con scrittura nitida e profonda, a scandire i giorni e i pensieri. Una cronaca che pure è sempre riflessione sulla vita e sui legami che ci regala.
Vivere, sembra dirci ad ogni istante questo sguardo di padre, è anche confrontarsi con l’idea della perdita. Perché affronta in quei giorni, il padre di Matteo, anche l’aggravarsi della malattia del suo di padre, cui non è potuto stare accanto come pure avrebbe voluto. Vivere, ci insegna, è anche confrontarsi con i propri limiti, con la propria idea di “eroismo” sapendo che il vero eroe, in tutta questa storia, è quel loro coraggiosissimo bambino, che ora vive con un tubicino impiantato vicino al cervello che gli consente di eliminare il liquido cerebrospinale in eccesso. Che infine dà loro la gioia dei primi passi, delle prime parole, e delle tante belle emozioni che, sempre comunque, un bambino che cresce sa dare. E sarà una vita di accudimento…
“Buone mani”, sono le mani di tutte le persone cha hanno aiutato Matteo a superare i momenti difficili. A vivere. Quelle del personale medico che di lui si è occupato e continua ad occuparsi (a proposito, i diritti d’autore che verranno dalle vendite del libro andranno alla Fondazione Bambino Gesù e alla fondazione Santa Lucia IRCCS). Quelle dei suoi genitori che davvero “non c’è fatica o sofferenza a sminuire l’ingombro di un amore”.
Un amore amoroso che continua a crescere, con i suoi bellissimi occhi spalancati sul mondo. Matteo ora ha cinque anni. Sì, l’ho incontrato…
L’ho incontrato che giocava in un giardino, in un cerchio di amichetti e adulti lì a seguirli. E questa ve la devo raccontare…
Premesso che sono piuttosto magra e negli ultimi mesi la cosa mi ha un po’ inquietata… Matteo mi ha subito “intercettata”, si è allontanato dal gruppo e mi è venuto deciso incontro porgendomi una boccettina d’acqua. “E’ un filtro magico!” mi ha detto convinto e convincente.
“Grazie! E se lo bevo che succede? Divento una principessa?”
“Se lo bevi diventi cicciottella!”
Magia delle percezioni che una sensibilità estrema regala…
Mi è capitato di ritornare in quel giardino. E sentire Matteo parlare di un “ponte con il cielo”. Il filosofo, qualcuno lo chiama. Non so se diventerà un filosofo, ma qualsiasi cosa farà, sono certa sarà il suo modo di dispensare saggezza e attenzione, con la sensibilità che mai perderà. E devo confessare che ancora torno, qualche volta, in quel giardino, a spiare brani di riflessioni, stupite e incantate, che questo piccolo guerriero sa regalare.
scritto per ultimavoce.it
Al mercato
Un racconto di Daniela Morandini. Come un flash. Ed è andata esattamente così…
“Al mercato, un giorno qualsiasi. Due bimbi di un anno più o meno, che appena appena camminano, si tengono per mano tra due file di scarpe. Uno sembra un cesello orientale, l’altro un guerriero in miniatura. Qualcuno si ferma a guardarli: sono così belli che sembrano finti. Un uomo impreca perché non riesce a passare. “Stronzo” gli fa una signora bionda vicino a me. “Scusi sa, ma quello lo conosco, è anche un padre, come fa a fare così?”
Dico qualche banalità sui bambini e la guardo. E’ giovane, ma non troppo. Ha occhi celesti larghi. E’ bella, anche se è troppo magra e ha i denti rovinati.
“Perché tanta cattiveria? Sa cosa succede poi?”. Aspetto la spiegazione e lei va avanti:
“Mio figlio si chiude in camera e si taglia. Il padre mi ha detto di riempirlo di botte. Ma scherziamo? In casa non ho nascosto niente. Sarebbe peggio. Il mio compagno è paziente, quando gli dice che dobbiamo stare insieme lui non va in camera a tagliarsi”.
La signora bionda è composta, ma comincia a piangere:
“Vedrà che risolverò anche questo”.
“Ne sono sicura” dico io. Mi presento e lei mi dice il suo nome, ma non lo ricordo. Ci salutiamo con un abbraccio e vado a comprare i broccoli, mentre i due bimbi che giocavano tra le bancarelle non ci sono più”.
Daniela Morandini
Un’idea tutt’altro che “bizzarra”…
“Un evento tutt’altro che “bizzarro” (questo l’aggettivo usato da Giorgia Meloni) e di straordinaria importanza perché professionisti sanitari, sulla base della rilevanza della dimensione della “salute mentale” nella vita quotidiana degli esseri umani, hanno evidenziato i gravi rischi che comporta per la stessa una condizione di restrizione, di detenzione di fatto per settimane su una nave di persone impedite di scendere a terra”.
Parole di Luigi Benevelli, psichiatra (fra l’altro fra i protagonisti del movimento dei diritti civili per i portatori di handicap e della costruzione del servizio sanitario nazionale) che, in un intervento pubblicato sul Forum della Salute mentale, controbatte alle dure parole del governo contro i sanitari che nel porto di Catania hanno disposto lo sbarco di tutte, ma proprio tutte, le persone migranti che si trovavano a bordo della “Humanitas” e della “Geo Barents”. Anche di quelle che il governo avrebbe voluto rimandare in mare perché “non fragili e non affette da malattie organiche”. Insomma, il “carico residuale” (quando le parole sono puro orrore…).
E forse non si è capita abbastanza la grande novità che Benevelli sottolinea: l’intervento di una squadra di sanitari per accertare anche le condizioni di sofferenza mentale e i rischi per la salute mentale delle persone in una condizione di restrizione, di detenzione di fatto. Che è cosa che riguarda anche chi malato e fragile non è.
E come non pensare anche a chi in condizione di restrizione, di detenzione lo è perché incappato, per un motivo o per l’altro, nel meccanismo del nostro sistema penale, che fa fatica a vedere altro che carcere, e carcere e carcere…
Come non pensare alle condizioni di sofferenza mentale e ai rischi per la salute mentale di chi è detenuto? Come non pensarlo per tutte, ma proprio tutte le cinquantaquattromila609 (dato al 31 marzo) persone ben serrate nelle nostre prigioni.
Perché in carcere, anche se si arriva sani, ci si ammala, nel fisico e nella mente. E’ cosa che chiunque abbia a che fare con il carcere sa bene. Come tutti sanno che la stragrande maggioranza delle persone detenute fa uso di psicofarmaci. Anche chi prima di mettervi piede magari gli psicofarmaci non sapesse proprio cosa fossero.
La detenzione già di per sé può comportare disturbo da adattamento (e sono psichiatri a dirlo) e sappiamo che in genere per ogni istituto di pena è previsto un solo consulente psichiatra, al massimo due negli istituti di grosse dimensioni…
Pensando dunque alle prigioni, come navi lasciate alla deriva in acque extraterritoriali, dove i diritti di chi è sulla terraferma qui sono tutt’altro che riconosciuti… e basta scorrere le cronache di un giorno qualsiasi, fra suicidi, denunce, violenze… tutte riassunte oggi dalle parole di Mauro Palma, Garante nazionale delle persone private della libertà, in un’intervista a L’Essenziale: “Il carcere è la risposta a tutto: alla malattia psichiatrica, alla dipendenza da alcol o droghe, alla povertà. E quando le sbarre non bastano, si usa la violenza”.
La proposta bizzarra dunque.
Tanto per cominciare riportare subito “le navi” in “acque territoriali” e lasciare che attracchino in porto, giusto per chiarire “sotto quale giurisdizione”… e poi ingaggiare squadre di psichiatri che ne varchino i cancelli col preciso compito di valutare i rischi, per la salute anche psichica, di chi è dentro. Esattamente come è stato fatto per i migranti della “Humanitas” e della “Geo Barents”.
Un rapporto onesto valuterebbe bene quanto male faccia il carcere all’equilibrio e alla salute mentale di chiunque vi abbia a che fare. Di chi è controllato come dei controllori, oserei dire, senza con questo voler giustificare le violenze dai controllori inflitte ai controllati, come cronache recenti ci dicono…
Un rapporto onesto farebbe replicare il “bizzarro evento”, che tanto ha scandalizzato il nostro presidente del consiglio, e potremmo vedere tutti scendere dalle nostre navi/carceri… nella speranza di imbarcarsi in un sistema di pena, non sarà mai troppo presto quando vi si metterà mano, che rispetti i diritti fondamentali delle persone, che ristabilisca la decenza, che restituisca alla pena quel che è della pena, che dovrebbe essere tutt’altro che minaccia alla salute fisica e mentale, tutt’altro che malattia e tortura…
A proposito delle lettere dal mare della pandemia…
Una profonda, attenta riflessione di Vittorio da Rios. A proposito delle lettere “dal mare della disabilità”. Uno spunto, come sempre, per Vittorio, di allargare lo sguardo sul nostro mondo…
“Francesca con il suo scritto mi ha posto con immediata apertura della porta della memoria a ricordi mai assopiti anzi sempre più vivi e potenti sia a fatti riconducibili alla mia esistenza di un settantunenne che ha avuto il privilegio di vedere “L’erba dalla parte delle radici” da sotto, quanto alla moltitudine di umanità incrociata, toccata da quella che una letteratura contemporanea definisce Handicap. Ora sia chiaro siamo innanzi, nonostante a indubbi processi evolutivi e di conoscenza, sia come approccio antropologico-sociologico, sia come conoscenza medico-scientifica, a paradigmi secolarizzati che richiedono tempi e metodologie per trovare definitivo accoglimento e comprensione come irreversibile condizione umana. Non posso non ricordare una straordinaria figura di uomo e scienziato che ho conosciuto, che in condizioni di incredibili quanto indicibili difficoltà con l’aiuto della amatissima mamma, che ne aveva colto fin da piccolo la straordinaria intelligenza si è laureato in medicina con successiva specializzazione in psicoterapia dell’infanzia e dell’età evolutiva. Parlo di Mauro Cameroni che all’età di circa due anni ebbe una paralisi celebrale che gli ha creato gravi ed irreversibili deficit motori, inibendogli il parlare, il camminare, e era continuamente martoriato da convulsioni di natura spastica. Scrisse un libro pubblicato nel 1983 da Feltrinelli “L’HANDICAP DENTRO E OLTRE”, con una bellissima introduzione di Giovanni Berlinguer il fratello di Enrico. Dove tra l’altro si legge: Sconsiglio la lettura agli Handicappati intellettuali e mentali, categoria ancora assai numerosa e di difficile recupero rispetto agli Handicappati fisici e psichici. L’Autismo… questa patologia che prende fin dalle prime settimane della gestione nell’utero materno della futura o futuro nascituro che inibisce spesso in modo irreversibile la capacità di comunicare, di parlare. è un fenomeno come rileva il Prof. Ernesto Burgio tra i maggiori Epigenetici scienziato e studioso dei processi cancerogeni, e dei meccanismi che determinano l’Autismo, in grande ed esponenziale crescita. Inquinamento ambientale, stress, determinato da sempre più frenetici ritmi di vita, introduzione nella biosfera di cellule artificiali di varia natura che non trovano simbiosi con le tradizionali cellule naturali che compongono il nostro organismo e di qualsiasi forma di vita biologica. Del resto ci ricorda con le sue ricerche, studi, e pubblicazioni di alto valore innovativo il Prof Burgio gli effetti devastanti determinati dall’attuale sistema finanziario-armiero-produttivo-consumistico che sta devastando il pianeta e tutte le sue forme di vita dovute a processi evolutivi di miliardi di anni, gli effetti gli avremmo tra decine di anni e saranno devastanti. Del resto già oggi constatiamo gli inizi di tale fenomeno, con riscontri di aumento di patologie cancerogene che prendono fasce di età sempre più giovani, di processi degenerativi del sistema nervoso centrale e periferico, con gravi e precoci forme invalidanti, con forme di obesità dovuta non a disordini alimentari, ma bensì a modificazioni del genoma e delle informazioni che arrivano al DNA. Del resto come evidenzia il Prof. Burgio gran parte dell’attuale paradigma medico scientifico la stessa trasmissione e formazione medico scientifica-farmacologica, è impostata ad agire sulle conseguenze di determinate patologie, e non sulle cause che le determinano. Ma questo paradigma riguarda un po’ tutto l’agire della cultura attuale basti pensare ad esempio al sistema giudiziario-carcerario. Innanzi a questi scenari che investono milioni di famiglie che si ritrovano con dei loro cari colpiti da patologie invalidanti di varia natura, occorre costruire strumenti culturali, economici concreti sinergie tra il pubblico e privato, e con gli strumenti necessari iniziare ad intervenire sulle cause che stanno devastando l’esistenza e quindi il futuro di un impressionate numero di creature umane. Un piccolo contributo su cui riflettere”
Vittorio da Rios
Dal mare della pandemia
“Perché non chiedere a persone con disabilità e ai loro familiari di raccontare il tempo del loro lockdown…”
Non avevo dubbi che l’idea fosse stata di Gabriella, Gabriella La Rovere, che è medico e scrittrice, madre di Benedetta, giovane donna con una rara forma di autismo secondario, che da sempre si batte per dare voce a chi vive situazioni cliniche e familiari difficili (ne abbiamo parlato https://www.ultimavoce.it/lettere-aperte-per-fare-uscire-da-se-il-dolore/):
E le lettere sono arrivate, e tante, e belle e vere, e commoventi, a volte ironiche, persino. Ma mai lamentevoli.
Ne è nato un libro, Lettere dal mare della pandemia (Avio Edizioni Scientifiche), curato insieme a Bruna Grasselli, docente di pedagogia, e Maria Matilde Nera, pedagogista. Un libro corale che ci fa affacciare su un mondo che non vogliamo vedere, e che nei mesi del lockdown ha ancora più sofferto di questa nostra cecità. Le persone disabili, come gli anziani… categorie che abbiamo cura di tenere ben confinate in recinti che non ci diano disturbo. Categorie di cui, nei giorni dell’infodemia che pur tanto ci ha travolti e storditi, si è parlato pochissimo, praticamente nulla. E le nostre prigioni sono diventate per loro una prigione nella prigione…
Lettere dal mare della pandemia riempie un vuoto, inaccettabile perché “non si può stare zitti”.
Perché non si possono rigettare nel nulla le emozioni, “la paura, la rabbia, la nostalgia, la speranza…” di due milioni e trecentomila famiglie italiane con una persona disabile grave. Se disagiati lo siamo stati tutti, potete immaginare di quale altro spessore il disagio di queste famiglie.
La paura più grande? Essere separati. E poi “la paura della morte, dell’improvviso dopo di noi, insieme al blocco totale delle attività esterne, delle occasioni di socializzazione, del cosiddetto sollievo, per un certo tempo, impossibilità di reperimento di farmaci antiepilettici, indispensabili alla vita”…
Un brano di una lettera tra tante.
“Caro Tommaso, questa lettera te la devo (…) quante volte in tutti questi anni ci siamo ricordati di essere una squadra, tu ed io? Moltissime. E una squadra affronta sempre gli eventi cercando di fare il meglio. In quest’ultimo scorcio di febbraio 2020 è come se per noi si fosse chiuso un sipario, come se, ancora una volta, tra la tua vita e il resto del mondo, si fosse alzata un’ulteriore barriera”. Così Irene Gironi Carnevale a suo figlio Tommaso. Irene che, sapendo che “la sola cosa che non ti avrei potuto togliere era uscire” ingaggia con altre madri una battaglia perché i loro figli potessero uscire di casa per motivi di sopravvivenza fisica e, soprattutto, psichica. La battaglia, quelle madri, l’hanno vinta, ma “era duro sentire insulti dalle finestre, subire controlli come fossimo criminali da parte di forze dell’ordine non all’altezza del proprio compito, dovendo esibire documentazioni umilianti e palesemente inutili” (a margine, questo in un paese dove la fitta rete delle tante restrizioni del lockdown ha allargato le maglie per permettere ai padroni di cani di accompagnare le loro bestiole intorno al palazzo… un problema, quello degli animali domestici, forse più facile da sentire…).
Molte, è stato sottolineato nel corso della presentazione del libro che si è tenuta questa settimana a Roma, le lettere inviate ai defunti. E chi non c’è più torna in “una corrispondenza d’amorosi sensi”.
“Caro nonno Dino, – scrive Alessandra Aliboni – ho una bimba di 12 anni, Annina, che ha una grave disabilità in seguito a cure fatte per la leucemia… le difficoltà sono state tante, ma lei si è presa la vita a morsi… e siamo andati avanti giorno dopo giorno, fino al 5 marzo 2020, quando tutto è stato chiuso… Per noi è stato come vivere un isolamento nell’isolamento. Servizi educativi, istituzioni… come se avessero ibernato tutto tranne noi. (…) ma Anna sorride, anzi ride di vero gusto. Ce la farà anche stavolta”.
“Caro nonno Giacomo – scrive Adriana Mattorre – di questi lunghi mesi ho accettato distanze e sudditanze psicologiche, sanificazioni e successive sacche di isolamento sperando in una soluzione ma ancora adesso siamo soli. (…) Di questo periodo spero che la società si lasci alle spalle l’egoismo a vantaggio di un sentimento di amore verso le diverse fragilità, aspetto un domani migliore senza emarginazioni sociali. Accetterò questa pandemia se ci sarà un cambiamento nella società”.
Belle lezioni di vita per tutti noi.
Tornando a Gabriella La Rovere. L’idea, spiega, è nata sfogliando pagine del diario lasciato dalla nonna, dove racconta i giorni della spagnola, la grande influenza, che fra il 1918 e il 1920 uccise nel mondo milioni di persone. Quel diario, riletto cent’anni dopo, è preziosa memoria, come preziosissima memoria da consegnare anche a chi leggerà “fra cent’anni” sono queste lettere, ché la memoria, scriveva Montaigne, è “ricettacolo e astuccio della scienza”.
Lettere dal mare pieno di ombre della pandemia, affidate alle onde del nostro sentire come un messaggio in bottiglia, che è “richiesta d’aiuto e testimonianza ai posteri di cosa è stata la pandemia da Covid-19 per quella parte di popolazione che è da sempre in emergenza”.
Leggerle oggi, intanto, è un invito a rispondere a questa richiesta d’aiuto, che se non è mai lamento, (non a caso il sottotitolo è “riemergere e guardare in alto”) è anche grido, per scuotere la nostra tanta, inaccettabile, disattenzione…
scritto per Ultimavoce.it
Fermiamo la strage dei suicidi in carcere
77 morti, fino a ieri. 77 suicidi nelle carceri italiane. E per lo più persone giovani, lì a scontare pene irrisorie. In carcere per uno scippo, per il furto di una cuffia, per quella dose di droga che, per quel manifesto della cultura illiberale che è la Fini- Giovanardi, ti fa finire in carcere. Persone “fragili” si commenta spesso. Una compassione che quasi si ritorce in colpa… eh, sì, troppo fragile per resistere alla “cura” dello stato. Che cura intollerabile lo è per tutti, anche per chi quella “cura” non si traduce in abbraccio di morte.
Fa impressione il silenzio che circonda questa strage. Ne parlano in pochi, solo chi di carcere si occupa da sempre…
Ristretti orizzonti ancora prova a rompere questo silenzio, lanciando un appello, al quale ci uniamo, ché “mai prima d’ora era stato raggiunto questo abisso”.
“Fermiamo la strage dei suicidi in carcere”, dunque. Primi firmatari Roberto Saviano, Gherardo Colombo, Luigi Manconi, Giovanni Fiandaca, Massimo Cacciari, Fiammetta Borsellino, Ascanio Celestino, Mimmo Lucano… e ancora filosofi, giuristi, penalisti, rappresentanti di associazioni che si occupano di diritti…
Un appello per scuotere il mondo della politica, questa politica che è sorda. “Sorda perché sul carcere e sulla pelle dei reclusi si gioca una partita tutta ideologica che non tiene in nessun conto chi vive ‘dentro’, oltre quel muro che divide i ‘buoni’ dai ‘cattivi’”.
Una politica sorda alle indicazioni che da tempo chi il carcere lo conosce pure sa dare, anche perché sa bene cosa si dovrebbe fare intanto per evitare o contenere questo massacro. In sintesi, “depenalizzare e considerare il carcere solo come extrema ratio, moltiplicare le pene alternative, dare la possibilità al cittadino detenuto di iniziare un vero percorso di inclusione nella comunità. Chi è in custodia nelle mani dello Stato dovrebbe vivere in spazi e contesti umani che rispettino la sua dignità e i suoi diritti”…
Perché, ne abbiamo parlato altre volte, molto di quel che avviene nelle carceri è “illegale”.
Qualcosa, per poter iniziare a dare sollievo a chi vive in condizioni che si fa fatica a immaginare, si potrebbe fare subito. Nell’appello vengono indicati alcuni punti:
1. Aumentare le telefonate per i detenuti.. Bisognerebbe consentire ai detenuti di chiamare tutti i giorni, o quando ne hanno desiderio, i propri cari. (oggi ogni detenuto (tranne quelli che non possono comunicare con l’esterno) ha diritto a una sola telefonata a settimana, per un massimo di dieci minuti.
2. Alzare a 75 giorni i 45 previsti a semestre per la liberazione anticipata.
3. Creare spazi da dedicare ai familiari che vogliono essere in contatto con i propri cari reclusi per valorizzare l’affettività.
4. Aumentare il personale per la salute psicofisica. In quasi tutti gli istituti vi è una grave carenza di psichiatri e psicologi.
5. Attuare al più presto, con la prospettiva di seguire il solco delle misure alternative, quella parte della riforma Cartabia che contempla la valorizzazione della giustizia riparativa e nel contempo rivitalizza le sanzioni sostitutive delle pene detentive.
Nulla di rivoluzionario, come vedete… solo un primo passo per arginare il massacro.
Per aderire basta firmare qui
https://www.change.org/p/fermiamo-la-strage-dei-suicidi-in-carcere-qui-ed-ora-si-pu%C3%B2-l-appello-del-dubbio?signed=true
Nulla di rivoluzionario, solo qualche passo per arginare l’indecenza. In attesa che si ripensi seriamente al sistema delle pene.
Personalmente sono convinta della necessità di pensare e realizzare infine un mondo senza carceri. Ripensare “questa strana pratica, e la singolar pretesa di rinchiudere per correggere, avanzata dai codici moderni”, come spiega Foucault. E non è utopia. Non è un caso (ce lo siamo dimenticati?) che la nostra costituzione parla di condanne e di pene, ma mai pronuncia la parola “carcere”. Che chi l’ha scritta, la nostra Costituzione, ben ne conosceva la barbarie. E teniamocela stretta, questa Costituzione, che ancora da qualche abisso ci tiene lontani…
scritto per Ultimavoce.it
Favolina
Daniela Morandini oggi ci regala una favolina… suggerimEnto di vie di fuga?
Ascoltate..
“Chaimaa aveva un marito lontano e un tappeto sottile, così sottile che, quando lo piegava, diventava piccolo come un sacchetto di farina. L’aveva tessuto e aveva creato il filo per intrecciarlo. Aveva tolto le spine alle foglie di un’agave, le aveva tagliate, calpestate, lasciate nell’acqua, asciugate e attorcigliate finché non erano diventate seta. Quando il marito le scrisse che stava per tornare, Chaimaa andò sulle cime dell’Atlante, raccolse i colori, le foglie di henné, la polpa del fico, il succo del melograno e tinse quei fili.
Seduta al telaio, costruì una trama come quella di un racconto, serrò i nodi e il tappeto iniziò a narrare storie che ancora dovevano accadere. Appena il marito ritornò, Chaimaa prese il tappeto sottile, ne tolse ogni piega e volò via”.
Daniela Morandini
Il casco
C’era una volta… e purtroppo qua e là ancora adesso… Bello e tremendo, questo racconto di Daniela Morandini….
ascoltate:
Per Natale, bisognava andare a mangiare dai nonni.
In ingresso c’era uno specchio inclinato, un attaccapanni a muro, una stufa di ghisa e un casco simile a quello del parrucchiere. In sala da pranzo c’era un tavolo intarsiato, una credenza déco con gli specchietti e una damina col cicisbeo sulle ante di vetro. Da un quadro, san Cristoforo, con Gesù bambino sulle spalle, proteggeva viandanti e barcaioli. Pare fosse l’ennesima mutazione di Anubi, il dio egiziano con la testa di un cane.
In soggiorno, il ritratto di un condottiero con la feluca in testa e una mano infilata nella giacca osservava ogni movimento. Ci rimasi male quando scoprii che non era Napoleone, ma un trisavolo, che aveva cacciato gli austriaci in una storia che non avevo ancora studiato. Il nonno si chiamava Valentino, come il divo del muto. Non era così bello, ma si dava un tono. Era stato un ufficiale medico della Prima guerra mondiale. Dal Friuli finì a Caporetto e poi a Crespino, proprio sul Po, dove Zeus aveva fulminato Fetonte mentre guidava i cavalli di Apollo. Sulla riva di quel fiume, Valentino incontrò Antonietta. “Ricorda che furlàn fa rima con vilàn” diceva la nonna, eppure la loro storia era andata a finire come in ogni romanzo d’appendice: si erano sposati ed erano nati mio padre e suo fratello. “Boia d’un paròn” bofonchiavano i figli dei contadini senza scarpe, mentre i due bimbi vestiti alla marinara volevano essere Lindbergh, sognavano la trasvolata atlantica e costruivano aeroplanini. Una sera di tanti anni prima, mi raccontarono, la nonna che non ne poteva più di non so cosa, prese uno di quei modellini, lo buttò per terra e lo schiacciò con i piedi: mio padre continuò a suonare il pianoforte, mentre il fratello spiava dalla serratura.
Ora Antonietta era una sorta di parallelepipedo con i capelli azzurrini. Indossava un abito grigio, largo, tipo grembiule. Aveva gli occhi piccoli, cerulei, liquidi, nascosti da occhiali con cerchi concentrici. Una trama di capillari rossi le disegnava la faccia e, forse perché era Natale, qualcuno doveva averle tagliato la barba perché, quando mi abbracciava, pungeva. Portava a tavola quei piatti chiusi dall’anno prima tra gli specchietti, la damina e il cicisbeo. Il brodo sapeva di muffa e dai bicchieri era meglio non bere. Per fortuna c’era il panettone. Quando poi mi davano il permesso di alzarmi, andavo a fare un giro. A sinistra c’era la camera da letto dove non si doveva mettere in disordine, a destra lo studio del nonno Valentino, dove non si poteva andare perché c’erano le medicine. Restava l’ingresso con quella stufa che mi piaceva tanto e quel casco collegato ad una specie di radio. Lo osservai tenendo le distanze, perché mi era stato detto di non toccare, e mi convinsi che quel marchingegno fosse troppo complicato per asciugare i capelli. Probabilmente era un’arma che i russi e gli americani usavano per la guerra che si facevano nello spazio, invece di pensare ai problemi della terra. Più tardi pensai che forse era stato usato per girare una scena di Metropolis, ma non mi risultava che i nonni conoscessero Fritz Lang. Ma qualche tempo dopo capii che quella macchina serviva per far uscire dalla testa non so quale malattia. Dicevano che dava la scossa, che mandava la corrente nel cervello e si guariva, ma non mi persuasero per niente.
Daniela Morandini
Cilento, il sogno di un ostativo
“Ho fatto parte di questo mondo nocivo, credevo di essere nel giusto, come un soldato obbedivo agli ordini, ma anche quando li davo ritenevo di comportarmi rettamente, secondo l’orientamento che avevo metabolizzato negli anni.
Sbagliavo, ma la mia ignoranza non mi consentiva di comprenderlo, perché l’ignoranza è una prigione peggiore della prigione stessa, non ti consente di avere un pensiero per fare delle scelte, cosa diversa dalla cultura.
Tutto ciò non legittima né tantomeno giustifica il mio passato…”
Ho fra le mani “Cilento, la mia Itaca”, biografia di Pasquale De Feo, in carcere dal 1983. La sua è la vicenda di un ragazzo “selvaggio” che voleva cambiare il suo mondo nell’unico modo, sbagliato, che conosceva. Si affilia ai cutoliani, i primi arresti, poi la condanna all’ergastolo. Ostativo.
Ho fra le mani il suo libro appena stampato, proprio oggi che in tutta fretta il governo vara il provvedimento sull’ergastolo ostativo, di fatto andando contro le indicazioni della Corte Costituzionale che lo scorso anno aveva infine chiarito come questa pena fosse fuori dal dettato costituzionale. Una pena, molto semplificando, che subordina la concessione dei benefici (permessi, libertà condizionale…) all’essere stati collaboratori di giustizia. “Pentiti”, diciamo, o collaboratori di giustizia, è una scelta processuale, mentre dimentichiamo quello che il vero pentimento è: ripensamento della propria vita che poco o nulla può avere a che vedere con la collaborazione.
E penso a Pasquale, che non è stato collaboratore, da anni in attesa di un primo permesso da uomo libero… Penso a lui e allo straordinario percorso compiuto in questi lunghi e tormentati anni, durante i quali un vero ripensamento sulla sua vita pure l’ha avuto. Ha studiato, molto ha letto. Molto ha letto soprattutto a proposito della storia d’Italia, interrogandosi sulle cause delle condizioni del nostro Sud e della gente che lo abita. Lo ripeto sempre, la cosa che mi ha subito colpita da quando lo conosco è la sua determinazione nel voler leggere la sua vicenda personale, la sua storia individuale, nell’ambito della Storia, quella con la S maiuscola. E non gli sarò mai grata abbastanza per avermi spinta a leggere, rileggere piuttosto oltre la retorica risorgimentale che abbiamo imparato a scuola, pagine della nostra storia. Aiutandomi a colmare, ad esempio, imperdonabili lacune a proposito della questione del brigantaggio e di tante atrocità rimaste a volte nascoste nelle pieghe della Storia ufficiale…
E mi ha sorpreso la sua capacità di ripercorrere tutta la sua vita nel bene e nel male, senza infingimenti. Sullo sfondo il Cilento, il paese dove la sua famiglia ha avuto origine, e dove spera di poter tornare. Un sogno sul quale rischia di cadere come una mannaia il provvedimento varato dal governo, pieno di ombre che già fanno parlare di illegittimità quando non di incostituzionalità (fra gli altri è molto chiaro a questo proposito l’ex ministro della Giustizia Giovanni Maria Flick).
Accenno solo a un punto, la necessità di dover accertare che l’ergastolano ostativo non abbia collegamenti con la criminalità organizzata, che è pur cosa legittima, ma con il decreto si stabilisce che sia il detenuto a dover dimostrare che così non sia. Non solo. Deve dimostrare che è escluso ogni “pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi”. Insomma, è la persona detenuta che deve fornire elementi di prova contraria. La pretesa di una probatio diabolica, per dirla con le parole dell’Unione delle Camere Penali, che Damiano Aliprandi riprende nella sua approfondita riflessione su “Il Dubbio”… “Ma come si può provare l’insussistenza del pericolo di un futuro evento di tal fatta? Non è questo un modo per rendere impossibile quello che pur si fa mostra di voler ammettere? Con ciò rifiutando in concreto ciò che la Costituzione richiede?”
E penso a Pasquale De Feo, dopo quarant’anni di prigione. Ma avete idea di cosa siano quarant’anni di prigione?
Non è naturalmente della necessità di una pena in risposta ai reati che si discute. Ma del suo senso sì. E oggi arriva questo decreto varato in tutta fretta per evitare il nuovo intervento della Corte Costituzionale che aveva dato un anno di tempo al parlamento per rivedere le norme sull’ostatività. Risolvendo le lentezze del parlamento, che già di suo aveva elaborato e non ancora approvato un testo (che il provvedimento del governo ricalca) già peggiorativo delle originali norme sull’ostatività, andando contro le indicazioni della Corte. E c’è un’amara riflessione che va fatta, e non è pensiero solo mio, ma di ben autorevoli giuristi e studiosi: il populismo penale nel nostro paese non è appannaggio della destra, ma atteggiamento trasversale, che tutto permea, tranne pochissime eccezioni, da destra a sinistra.
Oggi arriva il decreto che rende di fatto estremamente improbabile che un detenuto ostativo possa accedere a benefici penitenziari. E mi chiedo se il ministro Nordio, che oggi sostiene che si siano accolte le indicazioni della Corte Costituzionale solo perché “superato l’automatismo per cui per il semplice fatto di essere condannati per alcuni reati scattassero certi provvedimenti”, sia la stessa persona che tanto nettamente si era pronunciata contro l’ergastolo.
Pensando a Pasquale De Feo, alla sua Itaca, dove quanti l’abbiamo conosciuto e seguito in questi anni siamo convinti meriti di ritornare.
“Il mio pensiero va a coloro che per qualche motivo, da aver urtato la loro sensibilità fino alle cose più gravi, ho colpito. Chiedo loro perdono, ma prima voglio perdonare chi ha ucciso mio fratello, perché il perdono bisogna concederlo prima di chiederlo.
L’odio distrugge tutto ciò che si incontra sul proprio cammino, mentre il perdono libera l’anima e ti cambia la vita restituendoti tutti quei sentimenti belli per i quali nasce l’essere umano”.
Pensando a Pasquale che chiude dunque il suo libro chiedendo perdono, e dimostrando quanto grande è stato il suo cambiamento. E noi ne siamo sicuri. Se così non fosse, sconfitto sarebbe lo stato che tanti anni lo ha avuto in “cura”.
scritto per Ultimavoce.it