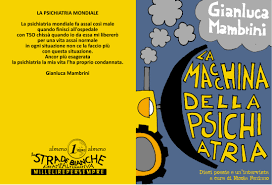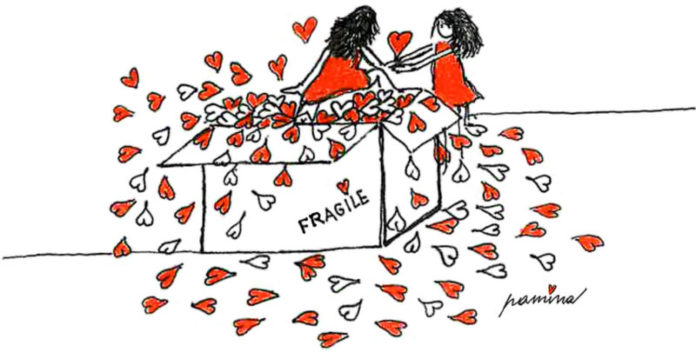“Ha una voce gentile, strizza un po’ le s tra le labbra. La pupilla sembra essere collassata nell’iride, colata un po’ più giù rispetto alla sua sede normale, o forse è solo un effetto ottico degli occhiali che porta, o forse è un qualche effetto degli psicofarmaci che prende o di quelli che ha preso negli anni addietro, oppure è la pupilla che ha messo in atto una protesta kamikaze contro quanto è stata costretta a vedere, oppure niente di tutto questo…”
Gianluca Mambrini… in questo scatto fulminante che, ne “La macchina della Psichiatria” (Millelirepersempre, Strade Bianche di Stampa Alternativa) ne fa Nicola Feninno,
E il suo fare gentile, un po’ fra il timoroso e il sorpreso, lo incontro al Festival della Letteratura Resistente che si è svolto a Pitigliano, l’ultima settimana d’agosto. Dove Gianluca ha un posto, proprio sull’ingresso de “Le Macerie”, nello spazio espositivo di libri e dischi, con un mucchietto dei suoi, di libri, ma anche pronto a dare una mano a tutti… pronto e ben compreso nel compito che si è dato di indicare a chi arriva le tracce dell’area devastata dal bombardamento alleato del giugno del ’44, luogo delle pietre e della memoria: “Scendete le scale, qua sotto…”
E quando è il suo turno, fra una presentazione e un concerto, si alza dallo sgabello, va verso il palco e legge versi delle sue poesie.
“La psichiatria si è presa per sempre l’anima mia, / lo dico con il mio cuore un po’ malinconico e malato (…).// Quando all’orizzonte appare l’auto della psichiatria/ non vedo l’ora che essa se ne vada via. / Per sempre davanti agli occhi miei/ prima che distrugga i sogni miei”.
E i suoi sogni, Gianluca, se li tiene ben stretti. Nonostante le tappe di una via Crucis che “mi fanno perdere la testa”. La morte del padre, la moglie che scappa via, la madre che perde la vita in un incidente stradale mentre è lui che guida, e qualcuno che lo accusa di essere stato lui ad ucciderla. E lui che cerca di impiccarsi, e il ricovero, racconta, per dieci anni in una RSA “praticamente una struttura per ammalati di Alzheimer, anche se io con l’Alzheimer non c’entravo niente”.
Poi la vita da barbone, che potete immaginare. Poi le sue visioni, che quelle non le potete immaginare… e i suoi sogni antichi, che magari poteva diventare pianista, o archeologo.
Scorro, mentre è sul palco a recitare le sue poesie, il Millelire curato da Feninno, che scopro essere fra l’altro bell’autore di reportage narrativi. E che qui lo accompagna nel suo parlare, fra i percorsi della sua vita e le pietre di Pitigliano, l’una e le altre piene di segni, che sono ferite, che sono dolori e rinascite, che sono anche, nonostante tutto, punti di fuga di bellezza…
E chissà che archeologo sarebbe diventato, se le cose fossero andate diversamente. Gianluca che così bene fa da cicerone, fra la Chiesa più antica del paese, dedicata a Santa Maria e San Rocco, che… “le immagini della Madonna avevano il potere di scacciare il diavolo”, e i vicoli e le pietre e.. “ora seguimi che ti faccio vedere le mura etrusche”. La narrazione della storia del paese costruito nella magia del tufo non può non aprirsi sui drammi della sua vita, e sono questi a prendere il sopravvento.
Così l’immagine di Padre Pio, che dice di aver visto una notte venirgli incontro fra i vicoli, si alterna all’immagine, ben più tremenda per lui che non quella di un fantasma, delle persone che… “venivano in piazza a rincorrermi con le loro medicine: devi prendere questa, devi prendere quest’altra”… e “mi giro e c’erano quattro carabinieri. Un medico, due infermieri, quattro carabinieri, tutti circondavano m. Io ero lì che piangevo a dirotto … a momenti mi strappano i pantaloni, e mi hanno fatto la puntura”. Il ricordo di cure e di TSO mal digerite, spesso vissute come violenza. Che pure diventano poesie.
“Il punturone è come quello di un calabrone / con effetto immediato di esso mi sono proprio annoiato/ in quanto dalla mia persona / deve essere accettato con le buone/ o con le cattive sperando che / esso non mi faccia morire. / Un’altra cosa la penso e voglio dire / il punturone mi fa proprio soffrire / adesso finisco e non ho altro da dire”.
Ora va meglio, è un po’ più libero, racconta.
Un po’ più libero. Il suo curatore finanziario è il sindaco di Pitigliano, subentrato al fratello che sembra curasse più i suoi interessi che quelli di Gianluca.
Ora va meglio, certo. E a guardare le persone che gli sono intorno, che intorno gli regalano gesti e respiri di normalità, che alla fine della sua lettura lo applaudono, penso all’idea della “città che cura”. Qui è un pezzetto di paese che in qualche modo si prende cura di lui. Come sta facendo anche quello straordinario mattarello che è Marcello Baraghini che ha avuto dalla asl il permesso perché Gianluca faccia il libraio presso la sua libreria e al suo banchetto di libri per la mostra.
“Tutte le mattine mi alzavo presto e andavo a bar, le compravo le ciambelline o il cornetto al cioccolato… aprivo il pianoforte e intonavo Rose rosse per te. Poi la baciavo in bocca. Tutte le mattine così. Perché ci tenevo al romanticismo”.
Sono arrivata all’ultima pagina di questa “Macchina della psichiatria”, quasi commossa. Alzo gli occhi e incontro quelli di Gianluca che, non mi ero accorta, era tornato al suo posto, e mi guardava come in attesa…
“Bello, molto bello, il tuo librino…” e ne ho presi tre, che sempre regalo in giro libretti che mi sono piaciuti.
Mi ha sorriso gentile, e come un po’ stupito, mentre mi sono sorpresa a frugare dietro i suoi occhiali spessi, a spiare, indiscreta, quella sua pupilla collassata nell’iride. E mi sono chiesta (non è la prima volta, mi è capitato anche curando testi dal carcere dove la narrazione viene puntellata qua e là da poesie) perché si sente il bisogno a tratti di scrivere in versi. La risposta l’ho trovata, tornando a casa, in un pensiero di Forster (Passaggio in India): “Gli uomini anelano alla poesia… vogliono che la gioia sia aggraziata e il dolore augusto, che l’infinito abbia una forma”.
Gioia aggraziata, dolore augusto, ché la vita è ben più che la miseria nella quale qualcuno a volte la vuole imbrigliare…
La magia del Festival delle Abilità
“Inclusione è una parola magica, quando esiste svanisce”, parola di Antonio Giuseppe Malafarina, giornalista, autore fra l’altro del blog del Corriere “Gli invisibili”. E meglio non si potrebbe cogliere lo spirito del Festival delle Abilità, che da venerdì 16 fino a domenica 25 affollerà il parco biblioteca Chiesa Rossa di Milano. Affollerà mi sembra la parola giusta, ché a scorre il programma c’è davvero da perdersi…
Fra mostre di fotografia, pittura, libri, e spettacoli di teatro, musica, danza, e poi laboratori, e talk, su famiglie, Yoga, sugli animali… (e comunque tutto il programma lo trovate qui https://festivaldelleabilita.org/ ) una rassegna di arti performative, si spiega, una festa di inclusione sociale che vuole permettere a tutti di mettere in risalto le proprie capacità a prescindere dalla propria condizione.
Insomma, un evento culturale che vuole valorizzare i talenti delle persone, con o senza disabilità.
Scorrendo il programma, ritrovo nomi incontrati nel periodo in cui mi sono occupata della trasmissione radiofonica “diversi da chi?”… e ancora mi riempie di ammirazione e di stupore sapere di Felice Tagliaferri, scultore di fama internazionale, oggi al festival milanese per guidare un laboratorio di scultura. Tagliaferri, che a 14 anni perse la vista. Avrete sentito parlare del suo “Cristo Rivelato”, una riproduzione del Cristo Velato della Cappella Sansevero, a Napoli, che lo scultore realizzò dopo che non gli fu permesso, in visita alla cappella, di toccare la famosa scultura di Sanmartino, unico modo per lui di apprezzarla. Il suo Cristo, che tutti hanno potuto toccare, rivelato a tutti, ma proprio a tutti.
La sua opera, il suo impegno, risuona qui come le note di un canto, che insieme a quello di tutti gli altri, compone quell’inno alla libertà che il festival vuole essere. La libertà di vivere come tutti “per riscrivere l’immaginario della cultura contemporanea, per farci dimenticare il prefisso dis dalla parola disabili e promuovere una cultura dell’abilità”.
E a proposito di inno alla libertà, fra tante suggestioni che arrivano scorrendo il programma del festival, mi fermo su un nome, che mi è stato segnalato da Martina Gerosa, infaticabile costruttrice di ponti: Gholam Najafi, giovane Afghano, a dieci anni fuggito dall’Afghanistan, e approdato in Italia, dove ora risiede, dove si è laureato, e fa lo scrittore, il traduttore, il mediatore culturale… Al festival presenterà il suo libro, “Il mio Afghanistan”. La sua storia, difficile come potete immaginare, il suo coraggio, inimmaginabile, e ora è qui, preziosissima voce, a spiegare che “l’intreccio di lingue e di culture ci salverà”..
Leggendo di lui, il mio pensiero va anche a Franco Bomprezzi, alla cui memoria è dedicato un premio. Franco Bomprezzi, eccezionale collega, scrittore e poi blogger, che adesso non c’è più. Costretto per una malattia fin da piccolo su sedia a rotelle, per tutta la vita ha lottato contro i pregiudizi. Ne avrete letto in molti i suoi illuminanti interventi, fra le tante cose che ha fatto, nelle pagine del Corriere. Risento il tono caldo e sorridente della sua voce…
“Ho anch’io il vizio di vivere”, diceva. Il vizio di vivere di un comunicatore. “Voglio essere un comunicatore, ossia una persona che mette in comunicazione mondi e culture che spesso non si parlano, non si ascoltano, non si conoscono”. E grande comunicatore è stato. Mi ha insegnato molto a proposito di abilità e disabilità, su come raccontarla, la disabilità, senza ipocrisie e falsi pietismi. Voglio ricordare ancora una volta che a Franco non piaceva per nulla quel “diversamente abile” che a un tratto è “qualifica” che ha iniziato a imperversare ovunque. “Non sono e non sarò mai diversamente abile”, insisteva.
E come non pensare a quanto questo festival è informato al suo pensiero. Il festival delle abilità, appunto. Delle abilità di tutti, che nulla e nessuno è “diversamente”…
Sarebbe piaciuto moltissimo a Franco questo incontro così affollato e ricco. Gli sarebbe piaciuto molto incontrare Gholam Najafi e intrecciare con lui pensieri.
Sì, sarà l’intreccio di lingue e di culture a salvarci. Diversamente saremo tutti “ugualmente” persi.
Non è sogno
Dall’ultimo numero di Voci di dentro…
https://ita.calameo.com/read/00034215419a33d1b7f3d
Nella IVCs del liceo scientifico e artistico Guglielmo Marconi di Foligno le ore di educazione civica del secondo quadrimestre sono state dedicate al tema della detenzione. Argomento complesso, non semplice, ma la guida della loro professoressa di italiano, Stefania Meniconi, ha condotto gli studenti in un interessante percorso, che molto li ha coinvolti. Tanti gli aspetti della questione affrontati e al termine del percorso gli studenti hanno incontrato i volti dei protagonisti di “Non è sogno”, il film di Giovani Cioni girato nel laboratorio le Nuvole del carcere di Perugia. “Parliamo sempre ‘del carcere degli altri’, ma sembra abbiano ben percepito, gli studenti, quanto il carcere sia riflesso della società, che il carcere siamo anche noi…” parole di Cioni, che questo film sta portando nelle scuole.
Un argomento, quello delle carceri e di chi vi è rinchiuso dentro, troppo spesso “allontanato”, quando non ignorato, nella nostra società che sempre più tende a considerare quel mondo altro da sé, come se non fosse invece della società prodotto e parte integrante. Ma siamo convinti che se le persone davvero sapessero, se davvero vedessero, se potessero confrontarsi con la verità bruciante di tante storie, con i propri dubbi e paure, anche, qualcosa in molti cambierebbe. Ed è vero, è proprio dai giovani che bisogna cominciare, dagli adolescenti, che vivono quell’età in cui spesso accadono “incontri” che cambiano la vita, semi qua e là gettati che rimangono acquattati nell’animo e nella testa, in attesa, in altro tempo magari, di germogliare… Lo dimostra il percorso seguito nell’istituto di Foligno, cui i ragazzi hanno risposto con tanta attenzione, con le loro emozioni, i turbamenti, le incertezze, le contraddizioni, anche, di chi si affaccia alle durezze della vita e si confronta con i limiti del bene, con la sconfinatezza, a volte, del male…
Abbiamo chiesto loro di raccontare questo percorso, di condividere con noi le loro impressioni, cosa ha significato, soprattutto, incontrare, sia pure solo attraverso un filmato, i sogni prigionieri dei protagonisti reclusi di un film girato in carcere…
A rispondere, sollecite, e sensibilissime, sono state ragazze. Ecco le loro voci, così come sono arrivate. Un buon punto di partenza, per avviarne, altre ancora, di riflessioni…
In questo secondo quadrimestre, l’argomento su cui si è aperto il dibattito, durante le ore settimanali dedicate a educazione civica, è stato la detenzione in Italia. Essendo un tema molto ampio, le discussioni tenute in classe hanno spaziato su più sotto-argomenti ed elementi caratteristici della prigionia. In primo luogo, abbiamo trattato il tema della pena di morte. Purtroppo, non ero presente quella mattina. Assente a questa prima discussione, non conosco il parere dei miei compagni ed è un peccato perché trovo molto interessante e costruttivo ascoltare l’opinione altrui. Personalmente sono contraria a questa pratica, credo sia un gesto disumano. Il tempo, più o meno lungo, trascorso in prigione dovrebbe essere un momento di presa di coscienza delle proprie colpe e dei propri sbagli. Il personale all’interno di queste istituzioni dovrebbe rappresentare un punto di riferimento, una guida per i propri detenuti, non lasciando nessuno da parte. L’uomo è una creatura molto orgogliosa, il pentimento è quindi un passo molto importante ed essenziale, spesso difficile da raggiungere se non si presentano situazioni adeguate. La prigione dovrebbe
essere un ambiente riabilitativo, persino per chi è condannato all’ergastolo. La condanna a morte non solo è un’attività brutale, ma non permette il percorso regolativo per cui la reclusione è stata creata. Inoltre, come abbiamo letto nel testo tratto da “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria, condannare un carcerato a morte non porta che a incrementare paura e orrore all’interno della società al di fuori di quelle che sono le mura penitenziarie. Spesso può frenare azioni immorali l’idea di una lunga reclusione in ambiente ostile e tormentato come quello del carcere, più che la pena di morte, per chi non ha niente da perdere.
Il secondo dibattito riguardava la storia di un prigioniero siciliano. Le notizie che abbiamo ricavato sono frutto di un’iniziativa intrapresa dalla nostra professoressa Stefania Meniconi la quale, tramite lettere, è riuscita a instaurare un rapporto con quest’uomo. In queste lettere racconta la sua storia, la causa della sua condanna e di come, in un periodo della sua vita, abbia tentato il suicidio. Ciò che ha fatto riflettere e ha dato inizio alla conversazione è come le circostanze in cui si nasce segnino inevitabilmente il destino di una persona. Circondato da ambienti e persone malfamate è caduto anch’egli nella trappola mafiosa. In particolare, mi ha colpito una riflessione esposta dalla professoressa alla classe. Essendo lei coetanea del detenuto, comparava la sua vita con quella del mafioso, riflettendo come esse, in entrambi i casi partite da zero, si fossero potute sviluppare in maniera così diversa. Io ho la fortuna di vivere in una città tranquilla, in una famiglia stabile economicamente che può permettermi di avere un futuro. Ma non tutti hanno queste possibilità e spesso c’è chi non conosce neanche la sensazione che si prova nello svegliarsi sereni. È ovvio che la sensibilità di una persona influisca sul comportarsi correttamente o meno, ma non metto in dubbio che certe circostanze mettano a dura prova la morale dell’uomo. Da fuori è difficile giustificare certi comportamenti perché non abbiamo motivo di rubare o uccidere, quando però diventano scenari ricorrenti nella tua quotidianità si può far fatica a distinguerli da ciò che è sbagliato. Spesso diventa una questione di vita o di morte e di fronte a ciò non sempre si è capaci di essere razionali. Con questo non voglio scagionare nessuno ma bisognerebbe aiutare chi non ha le stesse possibilità per cambiare qualcosa.
Abbiamo terminato questo percorso con la visione di un film di Giovanni Cioni. Un film molto particolare, con un’impostazione diversa rispetto a quelli che vedo solitamente. Mi è piaciuto molto perché si muoveva tra momenti più divertenti e momenti seri e profondi. Ho apprezzato il fatto che per ciascun detenuto non è stata mai specificata la colpa. Ladro, assassino, mafioso di fronte alla camera erano tutti uguali, quasi come se il fatto che fossero detenuti non rappresentasse il centro del film. Abbiamo visto sorrisi come lacrime, abbiamo visto rabbia come pacatezza. D’altronde sono uomini, dentro o fuori le sbarre. In molti di loro si percepiva la sofferenza e il rimpianto rispetto a ciò che identifica il proprio passato. Tutti erano d’accordo sul fatto che l’ambiente carcerario fosse orribile, speranzosi di poter rivedere la luce vera prima o poi. Per chi dovesse uscire mi auguro che il ricordo di questa loro “vita non vita” in carcere li spinga a iniziare un nuovo capitolo lontano da questi ambienti.
Margherita Macrì
Partecipare a questa unità didattica relativa alla condizione carceraria è stato molto interessante. Abbiamo avuto la possibilità di parlarne in classe e non solo, siamo riusciti a prendere visione del film “Non è sogno” di Giovanni Cioni… Il film in questione presentava l’indagine dietro le sbarre sulla condizione dell’uomo di fronte all’esistenza, alla realtà del mondo. Inizialmente ci troviamo in un film all’interno di un film che prende le mosse dalla ripetizione di un breve dialogo tra Totò e Ninetto Davoli in “Che cosa sono le nuvole” di Pier Paolo Pasolini e di alcune frasi tratte da “La vita è sogno” di Calderón de la Barca. A pronunciarle sono i detenuti del carcere di Capanne all’interno del Laboratorio Nuvole. Progressivamente dai testi si passa al vissuto di persone che si raccontano senza filtri. Vederli recitare è stato molto bello, si mostravano con tutta la loro semplicità, c’è chi per dire alcune battute aveva necessità di ripeterle allo sfinimento e chi aveva la necessità di sentirle pronunciare più volte per poi ripeterle. Tra un momento di risate e l’altro, Giovanni Cioni ha immortalato anche attimi di silenzio, quel silenzio che permette sia a noi che agli attori di riflettere, noi però vedevamo i volti degli attori, potevamo osservare la loro espressione facciale, i loro occhi che sembrano vuoti ma in realtà erano pieni di sentimenti a noi nascosti. Persone come noi, solo che vivono dentro una struttura per il loro passato, per punizione e per essere aiutati. Mi è piaciuto moltissimo. Sarà banale come pensiero personale ma per me la semplicità del film, degli attori e di tutto il resto mi ha particolarmente colpita, in particolar modo le risate e gli occhi degli attori. In generale penso che parlare di questi argomenti sia molto istruttivo, in particolar modo quando si presentano opportunità di apprendimento che stimolano i ragazzi ad essere più curiosi riguardo al mondo, riguardo alla realtà.
Altina Jusufi
Per noi giovani, penso che relazionarci con un mondo parallelo al nostro e molto
complicato, quello del carcere, sia un bel modo per renderci conto di ciò che provano
certe persone e delle situazioni difficili che la vita gli pone. Noi, che viviamo da
privilegiati, a volte nemmeno ci accorgiamo delle condizioni di alcune persone. Invece, in questa maniera, abbiamo potuto capire, almeno in parte, come vivono e come vengono trattati. Grazie al film di Giovanni Cioni abbiamo visto con i nostri stessi occhi alcuni dei carcerati. Mi sono commossa quasi tutto il tempo e ho pensato: cosa hanno fatto per meritarsi tutto ciò? Certo, è stata una loro azione a farli finire dove sono ora, ma sicuramente c’è qualcosa di molto più complicato e profondo dentro ognuno di loro che li ha spinti ad agire in una certa maniera. Sebbene ridessero e scherzassero, ho visto nei loro volti tanta tristezza, tanta sofferenza, tanta solitudine e soprattutto tanta speranza nel provare a rimediare ai loro errori e cercare di vivere una vita migliore di adesso. Con i loro sguardi urlavano libertà e serenità. Mi hanno colpito in particolare le scene in cui parlavano della terapia che dovevano seguire. Si vedeva in un colpo d’occhio che facevano uso di farmaci. Non erano veramente loro. Erano coperti da una maschera, che non li rende loro stessi al 100%. Inoltre, sono stati altrettanto profondi i momenti in cui parlavano ai loro familiari. I loro occhi splendevano di speranza e di amore per i loro cari. Spero con tutto il cuore che la vita permetterà loro di trovare un po’di felicità e di raggiungere il loro piccolo ma enorme desiderio: tornare a vivere, circondati da vero amore.
Marconi Valentina
Le prime scene del film sono dedicate alla recitazione, con tanto di ciack e di backstage, delle battute di “Cosa sono le nuvole” di Pasolini e de “La vita è sogno” di Calderon de la Barca e, partendo proprio da queste scene di metateatro, vengono raccontate poi le vicende dei carcerati.
Sentire la storia di Domenico, un ragazzo ergastolano che non ha più la possibilità di
crescere sua figlia, fa riflettere sul vero valore che hanno la famiglia e l’amore verso i propri cari. Egli, infatti, tramite una dolce lettera indirizzata alla figlia, le chiede di poterla incontrare con maggiore frequenza, in modo da poterla tirar su anche da dietro le sbarre.
Molto interessante è stata anche un’altra scena: due dei protagonisti discutono sul reato da loro commesso. Mentre uno sostiene di non essersi effettivamente pentito, l’altro afferma di essere felice di stare in prigione poiché il carcere l’ha aiutato a comprendere l’ingiustizia compiuta.
Sicuramente diversa sarebbe stata la pena riservata a Domenico, accusato di aver ucciso alcune persone, se in Italia fosse ancora in vigore la pena di morte. Atto orrido e disumano, che va conto i diritti fondamentali dell’uomo e che nega ai colpevoli la possibilità di pentirsi e di riabilitarsi, fine che invece ha la galera.
Proprio per parlare del compito che hanno le carceri di reintrodurre i prigionieri nella società, abbiamo avuto come ospite in classe il papà di Leonardo, che gestisce una cooperativa volta proprio alla riabilitazione dei detenuti. Essi così svolgono lavori utili alla società, come tagliare l’erba delle aiuole o ripulire le strade.
Elena Pescetelli
Il tema della prigione è un argomento molto importante ai giorni nostri, anche se non viene molto trattato. Il film mi ha lasciato forti emozioni, perché vedere che ci sono persone che si preoccupano di coloro che non sono molto stabili mentalmente, non è una cosa che si dà per scontata. Nel documentario vengono esposti tutti i pensieri ed i sentimenti dei carcerati, raccontando tutti i loro pentimenti e riflessioni. Questo filmato mi ha colpito particolarmente perché si vedono i prigionieri ridere e scherzare, provando ad imparare i copioni assegnati e ironizzando con gli agenti, molto comprensibili nei loro confronti. Mi ha impressionato notevolmente quando i detenuti raccontano le loro vecchie storie e le loro famiglie, Emozionano chi ascolta, riuscendo a farli immedesimare e capire il loro dolore.
Io credo che i carcerati debbano ricevere, oltre alle punizioni in prigione, anche del supporto psicologico, poiché le loro azioni vengono commesse molto probabilmente a causa di traumi passati o malattie mentali. Non penso che debba esserci l’utilizzo della pena di morte, se non per i colpevoli più spregevoli come gli stupratori o i serial killer. Questa esecuzione mortale non risolverebbe nulla, ma anzi risulterebbe comoda ai detenuti, che preferirebbero la morte ai lavori forzati. A mio parere essi andrebbero capiti e aiutati, specialmente se si vede un loro interesse nel cambiare.
Mercuri Rebecca
Sia la figura del detenuto che quella del carceriere infondono un senso di profonda separazione e solitudine, come se ci fossero, di fronte ad ogni persona, delle sbarre immaginarie che possono essere rappresentate da malintesi, giudizi, bassa autostima, paura del confronto e quant’altro possa essere considerato un elemento di divisione che ci fa sentire soli in un mondo che non riesce a comprenderci. Tanti sono i fattori che isolano l’uomo dal resto della comunità, dalle idee politiche all’orientamento sessuale, dal ceto sociale al livello di istruzione, dall’origine etnica alle idee religiose, eppure l’esperienza dei detenuti in questo carcere fa riaffiorare quel pizzico di solidarietà e di umanità e sperare in un mondo migliore. Che siano detenuti per uno scippo o per qualcosa di molto più grave, o che la loro pena sia all’inizio o quasi scontata del tutto, c’è tra loro complicità e comprensione che ci permettono di vedere che in fondo in fondo ognuno di noi ha bisogno di essere amato per quello che è. Riflettendo sul nostro vissuto, dopo due anni di pandemia, per tutti noi è come se fossimo stati in un carcere, a volte con l’impossibilità di relazionarci con gli altri, sia al lavoro che a scuola che in famiglia, a volte con l’impossibilità di dare un ultimo abbraccio a un nostro caro. Siamo costretti a stare lontani da tutto perché con le mascherine che nascondono i sorrisi, sempre più in silenzio, diamo voce ai social che in fondo ci dividono ancora di più, aspettando che le cose vadano meglio. Dovremmo provare a dare voce ai nostri sogni e alle nostre aspirazioni, Per far sì che le sbarre che ci dividono, un giorno, possano scomparire e che l’umanità e la solidarietà abbiano la meglio su tutto.
Giulia Onori
dal numero di settembre di Voci di dentro
https://ita.calameo.com/read/00034215419a33d1b7f3dhttps://ita.calameo.com/read/00034215419a33d1b7f3d
Pesci rossi
C’era una volta, e c’è ancora adesso… ancora un racconto di Daniela Morandini, che forse è fantasia e forse no… guardandosi intorno… ieri come oggi… e buna lettura!
“Quando ero piccola, si usava avere in tinello una vasca con i pesci rossi. Il tinello, vicino alla cucina, era la stanza dove si mangiava tutti i giorni. La vasca dei pesci era una palla di vetro come quella dei maghi, aperta sopra però. I pesci si compravano in un negozio dove c’erano anche dei canarini che, chiusi in una gabbietta, ciondolavano su un’altalena, perché chissà cosa aveva combinato. Vicino alla porta, con una zampetta legata ad un trespolo, c’era un pappagallo verde. Dicevano che sapesse parlare, ma non era vero. Se gli domandavi il suo nome, rispondeva “Loreto”, ma se gli chiedevi quanti anni avesse, ripeteva ancora “Loreto”. I pesci nuotavano in vasche lunghe e verdine. Ce n’era anche qualcuno nero, ma quelli non li voleva nessuno. Ce n’erano anche di minuscoli che, chissà come, si spostavano tutti insieme. Ma soprattutto c’erano i pesci rossi: andavano avanti e indietro tra un palombaro di plastica, un forziere dei pirati, e qualche anfora greca che forse qualcuno aveva messo lì per confondere le idee.
“Quale vuoi, bella bambina?” chiedeva il signore del negozio sempre con la stessa enfasi, cambiando solo le finali se si rivolgeva ad un maschietto.
Era fastidioso sentirsi chiamare bella bambina. Intollerabile poi se il signore ti dava un pizzicotto sulla guancia. Comunque era inutile fare storie e i pesci rossi sembravano tutti uguali. Bastava dire: “Quello” e lui inforcava un retino e ne pescava uno a caso. Il predestinato cominciava a dimenarsi, a sbattere la coda, a tentare di scappare, ma finiva in un sacchettino trasparente, con i manici, pieno d’acqua, da portare a casa dopo aver pagato.
C’era anche un altro modo per prendere i pesci rossi. Alla festa di santa Lucia, che poverina portava i suoi occhi in un piattino, oltre ai banchetti dei cammelli e dello zucchero filato, c’era quello delle lampadine fulminate. Chi ne colpiva di più vinceva una bambola o un elefante di pannolenci. Ma, anche se qualcuno ti aiutava a imbracciare quella specie di fucilino, era impossibile centrare il bersaglio. Allora ti davano il premio di consolazione: il pesce rosso nel sacchettino trasparente. Chissà poi perché ci si doveva consolare. Mica si diventa tristi se non si spara a una lampadina. Comunque, bisognava portare a casa quel sacchettino. Lo si agganciava al deflettore della macchina per non rovesciare l’acqua, mentre il premio, che non era mai stato in automobile, strabuzzava gli occhi. Arrivati in bagno, si apriva il rubinetto, si metteva la palla di vetro nel lavandino e vi si buttava il pesce rosso che, travolto dalla tempesta, rotolava su se stesso. Riempita per tre quarti e chiuso il rubinetto, la palla veniva asciugata e sistemata in tinello. Il malcapitato cominciava allora a girare in tondo senza fermarsi mai: non c’erano via di fuga e il vetro lo faceva sembrare ancora più grande. A ora di mangiare, si apriva una bustina di bricioline dal cattivo odore, ma che al pesce piacevano molto, perché si precipitava a galla con la bocca spalancata. In poco tempo diventava una specie di balena in miniatura, finché una mattina non lo trovavi galleggiare esanime.
Quando invece finiva la novità e ci si dimenticava di quelle bricioline, i pesci rossi sbiadivano: diventavano rosa, quasi giallini, addirittura biancastri. Anche loro, prima o poi, si sarebbero trovati a galla stecchiti. In questi casi venivano presi per la coda e buttati nel water, si tirava lo scarico e andavano a finire chissà dove. Spesso venivano sostituiti in fretta con pesci nuovi, per non far piangere i bambini, dicevano. Ma persino i più piccoli se ne accorgevano, anche se non commentavano, perché era meglio andare a giocare in cortile.
In quella palla di vetro i pesci rossi, oltre a mangiare e a nuotare
intorno a se stessi, espellevano filini sottili, scuri, che fluttuavano nella vasca. Per questo, bisognava pulirla tutte le sere. Dopo aver chiuso il tappo, si buttava il pesce nel lavandino con un po’ d’acqua. Si lavava la vasca nell’altro bagno, si metteva acqua nuova, poi si riacchiappava il pesce con le mani, non serviva neanche il retino, tanto era rassegnato il poveretto.
Una sera prima di cena, entrando di corsa in tinello, mi scontrai con mia madre che era appena uscita dal bagno e aveva ancora in mano la vasca rotonda. Fu un attimo: la palla di vetro andò in frantumi, mia madre si tagliò dappertutto, mi fulminò con uno sguardo e il pesce rosso morì sul tappeto”.
Daniela Morandini
Diario dalla prigione
“Solo tre mesi, ma sufficienti a provare concretamente cosa sia il carcere: un’istituzione totale fondata su principi non certo di giustizia, ma di repressione e di vendetta, controproducente per qualsiasi volontà di riscatto”.
Solo tre mesi, ma Nicoletta Dosio, in prigione perché “colpevole” di far parte del movimento che da trent’anni lotta in Val di Susa contro quell’ormai inutile quanto devastante “grande opera” che è il TAV, vede e vive sulla sua pelle quanto basta per capire tutto. E ci offre le pagine dello straordinario diario di quei tre mesi: “Fogli dal carcere. Il diario della prigionia di una militante No Tav” (RedstarPress)Nicoletta Dosio, che con i suoi 75 anni avrebbe potuto chiedere i domiciliari, ha scelto il carcere, per continuare ad essere al fianco di chi ha lottato e lotta con lei per la propria terra, ma anche perché non può accettare l’idea di fare della sua casa la sua prigione. E anche per questo motivo (può sembrare paradossale ma non lo è) il suo diario diventa un inno alla libertà. Come lo sono la sua fierezza, il suo non genuflettersi mai…
Lo sguardo di Nicoletta Dosio è attento, dolorante e fiero al tempo stesso. E anche dalla prigione su tutto si allunga, mai smette di ascoltare il respiro della sua Valle. Così il dentro e il fuori si incontrano, nel suo sguardo e nel suo sentire, che diventano, ancora, denuncia.
E’ fine d’anno quando Nicoletta entra in carcere, a Le Vallette, dove “niente comete per noi, niente streghe liberatrici, solo uno spicchio di luna crescente in uno spazio vuoto” mentre intravede oltre i blindi “ragazze venute dagli inferni dell’emigrazione che si trascinano appresso la loro povertà, più povere e dimenticate del bambino per il quale migliaia di anni fa i Magi si misero in viaggio guidati dalla stella”.
E racconta… la mortificante perquisizione corporale (essere nuda davanti alle guardie), l’essere condotta in ospedale in manette, la cattiva arroganza delle guardiane, i momenti di riposo da quel nulla che è il carcere.
E ascolta… i lamenti flebili e disperati, le voci dell’intimità infranta dei colloqui… E osserva a registra…
A proposito di C. , donna con problemi psichiatrici, rinchiusa in cella di rigore, “Mi chiedo come possa essere questa la medicina per il suo disagio di vivere. Ho chiesto di andare in infermeria. Passando, ho buttato un occhio attraverso lo spioncino. Lei, completamente nuda, giace su un materasso a terra, in una cella vuota. Dorme. Intorno fa freddo: il freddo di gennaio in carcere. Mi rivolgo alla secondina che mi sta accompagnando: “Perché?”. “Si impiccherebbe con le sue mutande”. “Ma è questa la soluzione?”. “Dosio, sbrigati!”.
Due anni dopo arriverà lo scandalo del “Sestante”, le denunce, la sua chiusura. Ma il carcere rimane tutto in questa allucinante violenta assurdità.
“Tra queste mura c’è davvero il mondo e non solo in senso geografico: vite sommerse, gettate dalla marea su questa spiaggia senza sole, dove si può davvero morire per un sì o per un no” .
Se il dentro è l’incontro con un’umanità sofferente che Nicoletta sa sempre accogliere e abbracciare, il fuori sono le voci dei tanti che le scrivono, e l’eco dei ragazzi, degli uomini e delle donne del Movimento che mai la lasciano sola. Il fuori sono anche i boschi della Valle, che sempre, mentre guarda oltre le sbarre, arrivano a riflettersi nei suoi occhi.
L’inno alla libertà, che arriva comunque da queste pagine, è accompagnato e composto da un intreccio di sussurri.
Come l’improvvisa brezza di liberazione, che accarezza tutte nello scoprire che l’uomo crocifisso (“esposto in ogni cella per ricordare che la vita è espiazione e che mettersi contro il potere significa prima o poi finire male”) non c’è più, deve essere sceso dal patibolo lasciando la croce vuota. Insomma, qualcuna era riuscita a portarlo via, a liberarlo, infine.
Come la poesia dello sguardo di una giovane sinti che raccoglie e fa volare via oltre le sbarre uno scarafaggio, mentre… “Perché non lo hai schiacciato?” domanda la guardiana. (Mi ha ricordato, questo, la fiaba di uno zingaro che costruiva gabbiette per uccelli, ma che non poté vivere di questo suo lavoro, perché riusciva a costruire solo gabbiette dalla quali gli uccelli potessero volare via).
Come, ancora, il bianco degli alberi di ciliegio che marzo riveste di fiori, ché “la primavera elude costrizioni e divieti”.
Commuove, leggendo la prefazione di Haidi Giuliani, la mamma di Carlo ucciso durante il G8 di Genova, l’intreccio di queste due voci di donna, il loro incontro fra una marcia sull’onda del movimento No Tav “lungo lo sterrato che conduce al cantiere” e un chiacchierare lieve di animali e di boschi.
Anche Haidi Giuliani conosce il carcere, per averne visitati molti durante il suo essere parlamentare (e magari qualche parlamentare in più sentisse il dovere di varcare quei cancelli…), anche lei sa bene che in carcere di criminali veri ce ne sono pochi. I più sono persone con le quali la nostra ricca civiltà è piuttosto in debito. “In debito con chi non è stato aiutato a progettare una vita degna di questo nome, con chi non è sato accolto, curato e messo nella condizione di lavorare serenamente”. Traspare dalle sue parole il legame di una forte amicizia, che è amicizia di sentire e di intenti, di due donne “dalla parte della vita”.
Nicoletta Dosio dal carcere è uscita ma, come anche da altri ho sentito dire, il carcere è cosa che poi sempre ci si porta dentro. Per Nicoletta, soprattutto, per un suo nobile sentire, ché “la liberazione o è collettiva o non lo è”. Perché quando lo si è conosciuto, il carcere, in tutta la sua bruttura, il pensiero di chi sai rimane lì dentro è cosa difficile da scrollarsi di dosso.
“Fogli dal carcere”, dunque. Che accende anche per noi una luce sul singolare accanimento giudiziario nei confronti degli attivisti del Movimento No Tav, che tutto va avanti nella nostra indifferenza. Ma vale la pena di leggere per capire qualcosa in più della nostra moderna democrazia.
scritto per Ultimavoce.it http://ultimavoce.it
a proposito dei suicidi in carcere
Ancora un intervento di Vittorio Da Rios, che ancora ringraziamo per tanta attenzione…
“Avevo trent’anni e per i strani casi della vita, “ma quasi niente è il prodotto del caso”, conobbi uno straordinario personaggio, un intellettuale scrittore, e diplomatico olandese. Di questa figura diventata poi un carissimo amico, a suo tempo ne ho già scritto delle riflessioni. Ora lo scritto come sempre stimolante e gravido di fondamentali domande di Francesca sul suicidio in carcere, mi stimola a rifare alcune considerazioni, e riflessioni. Martin, questo il suo nome, aveva trovato nell’alveo del fiume Piave la giusta “quiete” per terminare il suo capolavoro della maturità. E ricordo che lo accompagnai a spedire al suo editore a Rotterdam il dattiloscritto. Cosa trattava questo scritto? Della malattia mentale e delle sofferenze psichiche in generale e del suicidio in particolare. Martin aveva fatto grande esperienza concreta per molto tempo nei luoghi di “sofferenza”, strutture manicomiali, carceri ecc. E il suicidio lo aveva studiato da diverse angolazioni con grande conoscenza teorica: aveva studiato tutti i padri della psichiatria, della psicanalisi e della psicoterapia. Naturale il considerare che il suicidio è antico come l’Ominide, ma nell’era catastrofale odierna ha assunto forme e motivazioni inedite rispetto a paradigmi passati. Un primo aspetto da evidenziare del soggetto suicida: un attimo dopo se potesse ritornare indietro non lo farebbe più. Anche in luoghi di sofferenza estrema come è il carcere. Non intendo entrare dentro i complessi meccanismi della psiche umana, ma da molti “suicidi” mancati emerge questo. Quindi la tragica solitudine interiore, le insopportabili sofferenze psichiche e fisiche in taluni, casi e questo paradigma lo troviamo in carcere, porta momentaneamente ad esaurire tutte le risorse intellettuali culturali e psichiche positive. Il “buio” è totale, la solitudine irreversibile, quindi l’atto estremo. Lo stesso accade per i suicidi “liberi”, né più né meno, i meccanismi psicologici che lo determinano sono gli stessi. Ma la domanda che ci pone Francesca non può non inquietarci e porci innanzi a delle domande estreme che richiedono risposte altrettanto estreme quanto inedite rispetto ai paradigmi culturali odierni. Io mi permetto di citare ancora una volta un grande quanto innovativo giurista: Luigi Ferraioli, e la sua definizione di straordinaria sintesi dell’attuale realtà economica-finanziaria: “Creatrice dei crimini di sistema”. Quindi passiamo dal tradizionale paradigma della colpa “individuale” a responsabilità collettive. E i suicidi in carcere dove le creature sono irrimediabilmente “ristrette”, totalmente indifese, sono non solo responsabilità in fatto di diritto di questo oramai NON PIU’ STATO svenduto e oltraggiato nella sua essenza costitutiva GIURIDICA-COSTITUZIONALE, MA UN ASSASSINIO COLLETTIVO. I suicidi in carcere vanno ritenuti assassini collettivi. Per due semplici ragioni. Da un lato l’attuale paradigma giuridico-repressivo deve iniziare a riflettere e a darne conto. Se non esiste più lo Stato di diritto, e questo è incontrovertibile, con quale autorità oggi si mantiene ancora in essere il sistema carcerario? Dall’altro l’urgenza di ripristinare il DIRITTO previsto dalla Costituzione, nei suoi articoli portanti e fondativi di un efficiente e moderno STATO DI DIRITTO. Ma cosa si intente oggi per diritto e quindi organizzare il sistema di uno Stato moderno per dare a tutto concretezza operativa? E’ un compito collettivo cioè di tutti. Che prevede la deforestazione di gran parte del ginepraio dei testi giuridici, tanti di questi ripetitivi e inutili. E un ridisegnare dentro una riconquistata e matura civiltà del diritto nuovi trattati dei codici penali e civili. In sintesi un grande ripensamento con gli strumenti più evoluti della filosofia del diritto sugli strumenti filosofici-giuridici oggi e in futuro più idonei a determinare in tutte le pieghe della società a costruire concretamente l’applicazione del DIRITTO che prima di tutto è DIRITTO NATURALE: Giustizia sociale, equità economica, formazione culturale, costruzione del sapere collettivo, ecc. Questo agire nel tessuto sociale determina la totale inutilità del sistema carcerario. Retaggio feudale oggi non più tollerabile. E ci sia da stimolo riflessivo queste considerazioni di Lucrezio sulla conoscenza e l’errore. “Infine, se alcuno crede che niente si conosca, ignora anche questo, se si possa conoscere, perché ammette di non saper niente. Con lui dunque lascerò di discutere, perché da se stesso si pone con il capo al posto dei piedi”. Non meno tagliente questo assioma di Lucrezio sul pessimismo storico. “Così il genere umano si travaglia senza alcun frutto e invano sempre, e tra inutili affanni consuma la vita. Senza speranza non è la realtà ma il sapere che nel simbolo fantastico o matematico si appropria la realtà come schema e la perpetua”. Horkheimer e Adorno 1947. In “ragione e miseria” Franca Ongaro Basaglia, e Franco Basaglia fanno rilevare il momento storico in cui attraverso la dignità di malattia riconosciuta al delirio si da l’avvio a questo trasferimento della follia nella malattia mentale in cui la ragione consolida le fondamenta del suo impero, dà la possibilità di capire un altro aspetto essenziale del processo razionale, umanitario, scientifico, attraverso il quale la “malattia” diventa la mediazione tra la ragione ” dominate” e la miseria. Se la ragione borghese è diventata la Ragione Umana, il rapporto fra ragione e follia ” segregata ” è essenzialmente rapporto tra “Potere e Miseria” Un grazie di tutto cuore a Francesca per l’inesauribile impegno etico sociale che da sempre la caratterizza. Un caro saluto.
Vittorio Da Rios
Il suicidio in carcere
“Posso immaginarmelo/ tranquillamente crepato nel cuore / squassato nell’animo e tremante / davanti a tanto ferro grigio. //Posso credermelo ormai sfibrato / davanti a quelle regole diaboliche/che non aiutano nessuno/ …ed anzi spesso inducono / ad “infernali pratiche”. //Posso senza sforzo alcuno immaginare/ quella molle / morta corda / animarsi di colpo / “stiracchiarsi” / tirarsi sempre più / fin sulla barba / e poi oscillare fino a fermarsi…// Povero Nazareno! / Forse non riuscirà più a difendersi / ed ha scambiato il suo ultimo / tenue filo di speranza /con una robusta corda / da collo”.
Una poesia, che Giuseppe Perrone aveva dedicato all’amico Nazareno Matina morto il 3 giugno 2011 nel carcere di Spoleto. I parenti di Matina, ricordo, avevano comunque contestato il fatto che di suicidio si fosse trattato, e chiesto l’apertura di un’inchiesta. Che non so cosa sia poi successo, ma ritorna, per me, quella poesia ogni volta che so di persona che in carcere si è tolta la vita.
E quanto ritornano questi versi, in questi giorni che persone che in carcere si sono suicidate dall’inizio dell’anno sono già 48.
I numeri, forse li avrete già letti, ma non so… perché purtroppo non sembra notizia da prima pagina. Eppure…
L’ultimo aggiornamento di Antigone. Un suicidio ogni 5 giorni, quest’anno. E sempre più sono giovani, molto giovani, le persone che si tolgono la vita, fra i 20 e 30 anni, molte, in rapporto al loro numero, le donne. E sono persone che per lo più, ne abbiamo parlato, dovrebbero stare da tutt’altra parte. Persone fragili, magari con problemi di tossicodipendenza, come la giovane donna che qualche giorno fa si è tolta la vita a Roma.
Annus horribilis, verrebbe da dire…
Ma terribile, il tempo nel carcere, è sempre. Terribile e indecente, che altra parola non riesco a immaginare pensando a tanti “banalissimi” dettagli cui nemmeno si pensa, come essere chiusi in celle dove continuano ad esserci i water a vista, dove il caldo è soffocante, dove l’acqua è un miraggio… ma vi dice niente, a proposito di questa indecenza, il fatto che addirittura il carcere di S.Maria Capua Vetere ( sì, quello dei pestaggi dell’aprile del 2020 per i quali sono stati rinviati a giudizio un centinaio fra uomini della polizia penitenziari, dirigenti del Dap e funzionari dell’ASL) sia stato costruito senza una rete idrica?
Da alcuni giorni leggere la rassegna stampa di Ristretti orizzonti, puntualissima su tutto ciò che riguarda le prigioni, è come scorrere una fiera degli orrori. Ogni volta mi chiedo, c’è da chiedersi, come possiamo accettare tutto questo, come possiamo essere così indifferenti, come se chi è in carcere non appartenesse alla nostra stessa umanità. Una cosa è certa, quello che accade è il fallimento più evidente del ruolo punitivo dello stato.
E, a proposito di chi si toglie la vita nella cella di un carcere, vi giro ancora una domanda, che può sembrare una provocazione, ma forse non lo è: ma quando una persona si uccide in carcere, ed è alla “custodia” dello stato che una vita viene affidata, non è sempre e comunque di omicidio che si tratta? La risposta la trovo nelle parole del filosofo Giuseppe Ferraro:
“Non c’è delitto perfetto che non sia fare in modo che la vittima designata si faccia suicida. Il caso viene chiuso. Non ci sono prove, né impronte. Sono bastate le persecuzioni, le parole, l’esclusione, la mortificazione, l’emarginazione, la maledizione, la tortura. È stato alla fine la vittima a commettere il suo omicidio”. Così scriveva Ferraro in una lettera a Carmelo Musumeci (L’assassino dei sogni, lettere fra un filosofo e un ergastolano), in una riflessione dopo il suicidio proprio di Nazareno, che era persona condannata all’ergastolo, che è condanna al buio oltre il buio.
Ma penso le sue parole valgano per tutti, se il carcere per tutti è inferno che separa, che toglie voce alla parola e sequestra l’esistenza. “Nazareno… Si devono chiamare così tutti i suicidi che eseguono per prima mano la loro condanna a morte”, suggerisce Ferraro.
E quanti Nazareni ancora, prima che la nostra società abbia un sussulto e fermi tutto questo…
scritto per Ultimavoce.it
Quando comprenderemo che l’anomalia siamo noi…
Ancora a proposito dell’omicidio di Civitanova, questa riflessione di Vittorio da Rios, che come sempre è riflessione profonda, sull’uomo e sul mondo che abbiamo costruito… leggete..
“Quando comprenderemmo che l’anomalia siamo noi e non l’Africa nera da cui tutti discendiamo. Allora costruiremmo finalmente un nuovo grande planetario umanesimo. L’uomo inedito balducciano! Con l’auspicio che non sia già troppo tardi. Potremmo partire da qui per cercare di ragionare di quella tragedia a cui Francesca ha dedicato uno scritto di alto valore etico morale. Ma basta? O siamo innanzi a qualcosa di drammaticamente collettivo? Io ritengo di si, l’ominide da sempre uccide e spesso lo ha fatto croce in mano. Massacri stermini genocidi. Ma la tribù bianca è andata ben oltre nel secolo breve. Molto oltre quei crimini collettivi pur efferati compiuti in questi ultimi 5 secoli. Ha organizzato l’annientamento dell’altro su basi scientifiche-industriali. E molto pensiero filosofico scientifico e teologico ne ha dato giustificazione teorica. Non pochi intellettuali non hanno saputo più che potuto evitare l’entrata nell’aera catastrofale, l’era attuale del pensiero debole. Benedetto Croce ci ha illuminato con un assioma di valore assoluto. La filosofia è sempre presente nell’agire umano, e dove essa è grande e benefica Gli Stati e le società progrediscono. Dove essa è debole e deleteria ” il pensiero debole” gli Stati e le società si disgregano e vanno in rovina. Non è da qui che dovremmo partire per comprendere quella tragedia? Certo innanzi a un atto cosi crudele, estremo ed efferato, proviamo sgomento, indignazione, rabbia per come è maturato e nel modo in cui si è consumato, un simile assassinio. Francesca evidenzia alcuni tratti psicologici di quel giovane sventurato, come soggetto in grado di instaurare rapporti amichevoli ed affettuosi. Immaginiamo allora che fossero in quel momento applicati nei confronti di Alika Ogorchukwu, e anziché aggredirlo con il bastone che lo aiutava a camminare lo avesse invitato a bere un caffè e donarli se gli aveva i pochi spiccioli che possedeva, Chiederli come stava, da quale luogo proveniva, quale tribolazioni patite per arrivare qui da noi. Sorriderle e dargli la mano da uomo a uomo anzi da fratello a fratello. Come mai non è accaduto questo? Viviamo tutti noi in un clima di sistematica violenza di sistema. Mentre Alika veniva assassinato da un suo fratello “Bianco” sventurato vittima di questo criminale sistema collettivo di violenza e indifferenza, migliaia di fratelli di Alika: Indiani, Pakistani, creature provenienti come lui dall’Africa nera, vivono in condizioni sub umane, A gioia Tauro. Nell’ago Pontino e in molti altri luoghi del nostro paese, gli invisibili braccianti agricoli, senza di loro non si forniscono di verdura i supermercati di mezza Europa. Lavorando 9-12 ore al giorno per pochi Euro all’ora, le morti da calura e sfinimento non sono proprio infrequenti. E devono essere disponibili 24 ore su 24 perché i tir da caricare arrivano anche la notte. Vivono in baracche fatiscenti e quando va bene in roulotte. Chiedevo a un amico Indiano che ben conosce queste situazioni, dove sono le istituzioni del luogo l’autorità giudiziaria, perché questo non è sfruttamento è “Schiavitù” allo stato puro. Assenti mi disse sia Istituzioni che magistratura o quasi. E se tu ne togli 100 l’indomani ne arrivano 200 tale è efficiente l’organizzazione. Quando andiamo nei supermercati a riempire le borse di prodotti teniamo presente da dove arrivano e chi e come vengono prodotti. Certo non bisogna fare di ogni erba un fascio e chi scrive ben conosce la realtà produttiva agricola. La scoperta del futuro è come ha affermato Bronowski già nel 1975 la chiave dell’evoluzione umana? Questa essere legata alla previdenza tecnica degli Ominidi. Alcune decine di migliaia di secoli fa, essi sarebbero passati dal semplice uso degli arnesi alla loro fabbricazione e conservazione per l’avvenire. Da quel momento l’uomo, in grado di acculare conoscenze, di cambiare comportamento in funzione dell’esperienza e di formulare progetti, può dominare il ritmo di adattamento all’ambiente e sarà sempre più in grado di modificarlo. Cosa è accaduto perché questo processo assumesse le tragiche caratteristiche odierne di violenza, di guerre, di sterminio, praticato sia in forma collettiva che individuale, di manipolazione della mente umana e dell’ambiente in cui l’Ominide vive? Unica razionale risposta a tutte le violenze e uccisioni: Si è costruito io lo ripeto spesso; Il mostro tecnologico finanziario-armiero-produttivo-consumistico che oramai è fuori controllo all’uomo stesso Causa e motore della costruzione dei Crimini di sistema. Grazie infinite a Francesca alla sua grande coscienza critica. Sempre dentro le sofferenze e tribolazioni umane che e ci stimola a reagire e prendere coscienza cercando di “RADDRIZZARE IL LEGNO STORTO IN CUI SI RITROVA L’UMANITA”‘ Un caro saluto.
Vittorio da Rios
A proposito dell’omicidio di Civitanova… Razzismo, indifferenza, psichiatrie…
Alcune brevi riflessioni, e qualche domanda, a proposito dell’omicidio di Alika Ogorchukwu, l’uomo nigeriano ucciso a Civitanova Marche. Alcune riflessioni ora che piano piano la terribile vicenda via via sembra sbiadirsi, sommersa da altri incalzare…
Il nostro pensiero va alla moglie, alla famiglia e all’intera comunità nigeriana così comprensibilmente sconvolta… mentre, oltre il dolore di chi in questa tragedia è coinvolto, rimangono, pesanti come macigni, gesti e parole, definizioni che lavorano dentro di noi e plasmano il nostro modo di rapportarci agli altri, malintesi per arginare le nostre paure. Malattia, pericolosità, ad esempio…
Pensando al giovane che quell’omicidio ha compiuto, Filippo Ferlazzo. Chi lo ha conosciuto, chi conosce il suo percorso fra problemi di droga e difficoltà dei rapporti familiari, ne parla come di persona in grado di stabilire rapporti amichevoli, affettuosi, anche. Che avrebbe voluto fare il pittore… ché dipingere, leggo, era pure un modo per “sotterrare i suoi demoni”.
Ne ho parlato con Peppe Dell’Acqua che non si stanca mai di spiegare che bisogna sempre riportare e ripercorrere la storia della persona, per comprendere, collocare quello che è accaduto all’interno di una storia, e non si stanca mai di ricordarci che ognuno è la sua storia che non può annegare in un “marchio” da affibbiare in tutta fretta, per catalogare, allontanare da noi ciò che non vorremmo riconoscere come parte, nel bene del male, di noi tutti. A cominciare da tanta violenza, la quantità di sangue che ci viene rovesciata addosso quotidianamente da tv, cinema… e poi ritorna nelle cronache intorno…
Dopo l’omicidio, per Ferlazzo si è parlato subito di “persona socialmente pericolosa” e di “bipolarismo”, per dire di una condizione dove la persona vive oscillazioni periodiche di umore.
“Dare/ricevere subito una diagnosi psichiatrica, significa portare fuori da noi ciò che vorremmo non ci appartenesse. Ricorrere subito a una diagnosi psichiatrica significa dire che la malattia è l’unico colpevole e dimenticare tutto il resto. Di questo dovremmo liberarci, perché la perizia psichiatrica porta su un altro binario che subito cancella la storia individuale e si perde la strada nella normalità. Dimenticando che il gesto di uccidere è cosa che fa parte dell’umanità, con tutte le conseguenze che per ognuno questo deve comportare. Penso ai poliziotti statunitensi che hanno ucciso uomini di colore…”
E l’immagine, fra le tante, che subito torna, quella dell’omicidio di George Floyd. Pensateci, il gesto ultimo è esattamente lo stesso… di uomo che si accanisce, soffocandolo, su altro uomo. Bianco l’uno, nero l’altro. Anche per l’omicidio di Civitanova questione di razzismo?
“Quel giovane ha subito voluto dire di non essere razzista, ma, mi chiedo, avrebbe fotto quello che ha fatto se quell’uomo non fosse stato nero? C’è un razzismo diffuso che è dentro di noi, e che agita tensioni e conflitti nel nostro mondo interno. Chiediamoci se le cose sarebbero andate diversamente se l’altro fosse stato un bianco… il razzismo diffuso è anche dentro di noi e condiziona quando meno ce lo aspettiamo il nostro sentire e i nostri comportamenti… riguardate quel video, dove tutto accade in quattro, cinque minuti…”.
E come non pensare che a comporre quel razzismo diffuso è anche l’indifferenza, e le responsabilità individuali si intrecciano a quelle collettive. Non sarebbe intervenuto nessuno anche se la vittima fosse stata un bianco e viceversa l’aggressore persona di colore? Non ho la risposta certa, ma chiediamocelo…
Ritornando alla questione del disturbo mentale, che da un lato, come si diceva, sposta il male e la colpa lontano da noi, dall’altra viene subito messa in gioco ad invocare irresponsabilità, Dell’Acqua mi ricorda un’intervista di qualche tempo fa di Franco Rotelli, a proposito di una serie di tragedie italiane… insomma, la scia di sangue della nostra quotidianità…
“A me molti di questi protagonisti, spiega Rotelli, sembrano davvero matti. Persone fuori di testa, malate. … E’ gente che non metterei tanto dentro ciò che noi indichiamo quotidianamente come persone normali. Ma, attenzione, l’essere matti tutto dice tranne che uno status di irresponsabilità. Beh, gli avvocati di difesa parlano in quasi tutti i casi di infermità mentale, di incapacità di intendere e volere… No, no. Nella mia decennale esperienza di psichiatra non c’è matto che nel commettere un illecito grave, un crimine, non sapesse che cosa stava facendo. E’ una menzogna quella della ‘incapacità di intendere e volere’ che si rovescia sulla malattia mentale aprendo tutti i varchi alla marginalizzazione delle persone malate e ogni tipo di violazione dei loro diritti – tanto non sono ‘responsabili’. Con la ‘irresponsabilità’ si innesca poi un orrore giuridico con la scomparsa dal processo e dal giudizio della persona incriminata, cosa che non ha alcun senso”.
Non c’è matto, dunque, che nel commettere un illecito grave, un crimine, non sappia che cosa stia facendo. E le parole che, ho letto, Filippo Ferlazzo ha pronunciato in qualche modo sembrano confermarlo: “Quello che ho fatto è la mia condanna”.
“Quasi desiderio- conclude Dell’Acqua- di una porta che si chiuda alle sue spalle e lo lasci nella solitudine del suo pensare. La condanna è ritornare col pensiero sulla propria colpa, e dovrebbe avvenire in un modo o nell’altro…”
E noi che, ricorda Dell’Acqua, siamo tutti figli di Caino, piuttosto che catalogare per allontanare da noi cosa che ci fa paura, dovremmo cercare di comprendere:
“Sto parlando di una comprensione che ci aiuti a dire con Jean Paul Sartre che “tutto ciò che è umano ci appartiene”. Solo la comprensione nella normalità può esorcizzare la paura che avvertiamo, dolorosa e “tragica” dentro di noi ed intorno a noi”.
E questo appartenerci non può naturalmente significare giustificare. Significa altro, e ritorno alle parole di Rotelli, che respinge per le persone con disturbo mentale l’orrore giuridico dell’irresponsabilità:
“Visto che c’è il carcere come luogo di espiazione, devono andare in carcere come le altre persone che commettono reati. Un carcere magari che sia in grado di costruire sul soggetto la pena. Soggettivare che può voler dire considerarli cittadini come tutti gli altri – nei diritti e nei doveri – nella buona e nella cattiva sorte”.
Visto che c’è il carcere. In attesa, per noi che lo riteniamo necessario, che il sistema delle pene cambi per tutti. Ma qui si aprirebbe altra pagina, a proposito della nostra incivile civiltà…
Scritto per Forum della salute mentale